sett. 2022 – pp. 180
Passoscuro
Massimo Ammaniti
«Questi bambini sono stati spogliati di tutto: della famiglia, dell’istruzione, del gioco, dei piccoli segreti, insomma della vita. E prima di iniziare un lavoro di riabilitazione è importante aiutarli a ritrovare la propria identità, a uscire dall’anonimato della non esistenza: che altro può fare un neuropsichiatra che si occupa di bambini in un ospedale come questo?»
RECENSIONE :
DA :
SATIS
FICTION
Massimo Ammaniti. Passoscuro. I miei anni tra i bambini del Padiglione 8
MASSIMO AMMANITI. PASSOSCURO. I MIEI ANNI TRA I BAMBINI DEL PADIGLIONE 8
I ricordi dell’incarico presso il Reparto dei minori irrecuperabili dell’Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà, a Roma, sono al centro di Passoscuro. I miei anni tra i bambini del Padiglione 8, libro di Massimo Ammaniti in uscita per i tipi di Bompiani. Un testo che fa i conti con l’orrore e la sofferenza di bambini che erano letteralmente rinchiusi e confinati in quell’istituto, spesso legati ai letti e seminudi, abbandonati dalle famiglie. Il primo incarico di Ammaniti durò un solo giorno, il secondo, invece, a partire dal 1972, durò due anni, e rappresentò il tentativo di riconsegnare a quei bambini reclusi una vita migliore, prendendo le forme di un vero e proprio combattimento, scandito da momenti drammatici. Si trattava di cambiare profondamente il quotidiano del reparto, spingendo per stravolgere regole, abitudini, comportamenti, aprendolo anche all’esterno, all’insegna di una rivoluzione che prendeva la mosse da quella critica radicale delle istituzioni manicomiali propria dell’antipsichiatria e della lezione di Basaglia. Una toccante quanto preziosa testimonianza di Ammaniti, che si riconnette anche alla dimensione più intima e familiare dell’autore.
#
Forse non è stato solo il caso a farmi scendere le scale della Neuropsichiatria infantile per occuparmi di bambini. Sempre più mi convinco che le apparenti casualità nascondono percorsi sotterranei che seguiamo senza rendercene conto. Questo pensiero mi fa tornare in mente Le vie dei canti di Bruce Chatwin, in cui lo scrittore inglese racconta di come gli aborigeni australiani si spostino seguendo un labirinto di passaggi visibili solo ai loro occhi. Anche nel mondo occidentale non sempre le nostre vie sono percorribili con gli occhi della ragione, spesso c’è un filo nascosto che attinge dal nostro inconscio e dallo scenario dei sogni. Adesso che mi sto avviando verso l’ultima tappa della mia vita mi sembra di rintracciare questo filo che ho ripetutamente riannodato, e che mi ha portato e mi porta ancora oggi a occuparmi dei bambini. Evidentemente ero già orientato verso quella scelta, il caso è solo intervenuto per dare un ulteriore impulso, mettendomi a contatto con genitori che da me si aspettavano di ricevere risposte sulle condizioni dei propri figli. Le domande erano sempre le stesse, anche se formulate con parole e toni diversi: “Che cos’ha mio figlio che ancora non cammina?” oppure “Perché non parla se gli altri bambini della sua età già lo fanno?”.
Nei loro volti coglievo preoccupazione e angoscia verso quelle creature che tardavano a crescere e a conquistare le tappe del normale sviluppo. Di fronte a quei figli in cui fin dalla gravidanza, e anche prima, avevano riposto tante aspettative ora delus e, avrebbero voluto trovare un medico che li rassicurasse e indicasse loro la strada da percorrere. Era la stessa muta richiesta che aleggiava nello studio pediatrico di mio padre, dove i genitori in attesa di un parere si chiedevano se sarebbe stato in grado di guarire o meno i loro figli. In quegli incontri avvertivo qualcosa di magnetico che andava al di là delle parole, un lessico fatto di sguardi, di espressioni del viso, di gesti che era la premessa necessaria alla diagnosi. Tra i miei ricordi d’infanzia ci sono questi pazienti seduti sulle poltrone e sulle sedie nell’ingresso del nostro appartamento, in attesa di essere chiamati dall’infermiera.
e, avrebbero voluto trovare un medico che li rassicurasse e indicasse loro la strada da percorrere. Era la stessa muta richiesta che aleggiava nello studio pediatrico di mio padre, dove i genitori in attesa di un parere si chiedevano se sarebbe stato in grado di guarire o meno i loro figli. In quegli incontri avvertivo qualcosa di magnetico che andava al di là delle parole, un lessico fatto di sguardi, di espressioni del viso, di gesti che era la premessa necessaria alla diagnosi. Tra i miei ricordi d’infanzia ci sono questi pazienti seduti sulle poltrone e sulle sedie nell’ingresso del nostro appartamento, in attesa di essere chiamati dall’infermiera.
Magra e ossuta, nonostante quella voce un po’ gracchiante che a me faceva pensare a una strega, Concettina sapeva rassicurarli. Dato che avevo il divieto di fermarmi, io passavo veloce e guardavo di sottecchi bambini e genitori. Erano soprattutto le madri ad accompagnare, i padri si vedevano poco e quando venivano rimanevano in piedi, dando l’impressione di avere fretta di andare via. C’era grande varietà tra chi si affidava alle cure di mio padre: genitori della borghesia romana e persone di estrazione più umile, che a volte venivano dai paesi attorno a Roma. Lo capivo dall’abbigliamento ma anche dal modo di parlare e di gesticolare. A volte, chi arrivava dalla campagna portava in regalo un pollo o delle uova avvolte in fogli di giornale. I bambini erano un po’ di tutte le età: c’erano lattanti in braccio alle madri che piangevano disperati e bambini più grandi con aria intimidita e preoccupata perché consapevoli di dover andare dal medico. E poi ragazzini alle soglie dell’adolescenza ma ancora in pantaloni corti, privi di quella spavalderia che contraddistingue i loro coetanei di oggi, in jeans, T-shirt e scarpe da ginnastica. Per me erano presenze estranee ma al tempo stesso familiari. Qualcuno a volte lo riconoscevo perché tornava in più occasioni, e io, mio fratello e mia sorella ci chiedevamo se fosse ancora malato e papà non lo avesse curato bene.
 Per noi era una specie di palcoscenico quotidiano, pieno di attori con cui non potevamo interagire, personaggi pirandelliani in cerca di autore. Ma il loro copione era fisso: esprimevano dolore, preoccupazione, a volte anche speranza. Il regista di quello spettacolo, invece, mio padre, non lo vedevamo quasi mai, perché se ne stava nel suo studio, da cui provenivano i pianti inconsolabili dei piccoli pazienti. Li immaginavamo sottoposti alle torture più dolorose, pur consapevoli che quello era l’unico modo per guarirli. Mio padre teneva molto ai suoi pazienti e la nostra vita era condizionata dalla loro presenza. Ci ricordava continuamente: “Non fate rumore, ci sono i clienti.” Non potevamo giocare a palla né alzare la voce. I suoi pazienti entravano spesso nelle discussioni di famiglia perché mia madre non li avrebbe voluti in casa, anche se l’alloggio era separato dallo studio. Temeva che noi bambini potessimo essere contagiati dai malati. Quando scelsi gli studi di medicina non avevo in mente di seguire le orme di mio padre, mentre lui dava per scontato che avrei raccolto il testimone e lavorato nel suo studio. Quando lo vedevo fare un’iniezione oppure mettere dei punti a un bambino ero colpito dalla sua abilità manuale e dalla sua predisposizione alla cura dei piccoli malati. Per me è sempre stato diverso, e quando qualcuno si faceva male, soprattutto se si trattava di bambini, preferivo mantenere una certa distanza fisica invece di darmi da fare per aiutare. E infatti, scegliendo psichiatria per l’internato e la tesi, avrei evitato di occuparmi di malattie fisiche.
Per noi era una specie di palcoscenico quotidiano, pieno di attori con cui non potevamo interagire, personaggi pirandelliani in cerca di autore. Ma il loro copione era fisso: esprimevano dolore, preoccupazione, a volte anche speranza. Il regista di quello spettacolo, invece, mio padre, non lo vedevamo quasi mai, perché se ne stava nel suo studio, da cui provenivano i pianti inconsolabili dei piccoli pazienti. Li immaginavamo sottoposti alle torture più dolorose, pur consapevoli che quello era l’unico modo per guarirli. Mio padre teneva molto ai suoi pazienti e la nostra vita era condizionata dalla loro presenza. Ci ricordava continuamente: “Non fate rumore, ci sono i clienti.” Non potevamo giocare a palla né alzare la voce. I suoi pazienti entravano spesso nelle discussioni di famiglia perché mia madre non li avrebbe voluti in casa, anche se l’alloggio era separato dallo studio. Temeva che noi bambini potessimo essere contagiati dai malati. Quando scelsi gli studi di medicina non avevo in mente di seguire le orme di mio padre, mentre lui dava per scontato che avrei raccolto il testimone e lavorato nel suo studio. Quando lo vedevo fare un’iniezione oppure mettere dei punti a un bambino ero colpito dalla sua abilità manuale e dalla sua predisposizione alla cura dei piccoli malati. Per me è sempre stato diverso, e quando qualcuno si faceva male, soprattutto se si trattava di bambini, preferivo mantenere una certa distanza fisica invece di darmi da fare per aiutare. E infatti, scegliendo psichiatria per l’internato e la tesi, avrei evitato di occuparmi di malattie fisiche.
3 AGOSTO 2022
Futuro Antico. Intervista allo psicanalista Massimo Ammaniti
Futuro Antico. Intervista allo psicanalista Massimo Ammaniti
Ludovico Pratesi
LO PSICANALISTA MASSIMO AMMANITI RIFLETTE SULLA SUPREMAZIA DELLA TECNOLOGIA E SULL’IMPORTANZA DEL RAPPORTO TRA IL CORPO E LA MENTE NEL CICLO DI INTERVISTE CURATO DA SPAZIO TAVERNA

Massimo Ammaniti è nato a Roma nel 1941. È psicoanalista e medico neuropsichiatra infantile. Attualmente è considerato uno dei più noti psicoanalisti italiani specializzati nell’età evolutiva. È Professore Onorario di Psicopatologia dello sviluppo presso l’Università La Sapienza. Oltre a svolgere la sua attività come docente universitario e la sua professione in qualità di psicoanalista, Massimo Ammaniti è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative, tra le quali Adolescenti senza tempo (2018) e Il corpo non dimentica (con Pier Francesco Ferrari, 2020).

Ritratti del Fayyum. Aline. Ägyptisches Museum Berlin Altes Museum
Quali sono i tuoi riferimenti ispirazionali nell’arte?
Direi che un’area che mi ha sempre interessato e coinvolto è quella della ritrattistica, cominciando dai volti del Fayum, che hanno dei tratti molto attuali, fino ai ritratti dei pittori del Rinascimento come Lorenzo Lotto, Antonello da Messina e Rembrandt, con una profondità psicologica che mi ha colpito. Nella contemporaneità mi interessa molto Lucian Freud, non solo per la parentela con il nonno Sigmund ma soprattutto per la sua maniera di dipingere l’intensità del corpo e del viso, che trasmettono la psicologia dei personaggi. Si tratta di persone del suo entourage, delle quali sottolinea l’imperfezione dei corpi per mostrare la verità dell’esperienza interiore. I corpi protagonisti dei suoi dipinti riflettono quella che chiamo “conoscenza implicita”, relativa a ciò che viene prima delle parole quando due persone si incontrano. Come diceva Merleau-Ponty, “il corpo parla” e influisce sulle relazioni umane. A questo argomento ho dedicato un libro, Il corpo non dimentica, per capire quanto il corpo sia protagonista nella nostra vita.
Qual è il progetto che ti rappresenta di più? Puoi raccontarci la sua genesi?
Il progetto che mi ha coinvolto maggiormente è stato il movimento antistituzionale degli Anni Sessanta, attivato e stimolato da Franco Basaglia contro le istituzioni manicomiali. Un uomo come lui riuscì a lottare contro le varie forme di emarginazione e di segregazione dei malati mentali e dei bambini chiusi negli istituti. Ci fu un grande movimento all’interno del mondo psichiatrico che coinvolse l’intero Paese e cambiò la stessa concezione del malato mentale, al quale Basaglia ha ridato un volto umano. Io stesso ho chiuso un reparto di bambini nell’ospedale psichiatrico di Roma, dove vivevano in un stato di abbandono, a volte anche legati. Lo racconto nel mio prossimo libro, Passoscuro. La mia vita tra i bambini del Padiglione 8, in uscita a settembre.
Che importanza ha il genius loci all’interno del tuo lavoro?
In un mondo globalizzato e immateriale il genius loci potrebbe sembrare un concetto superato, eppure ognuno di noi vive con le radici che ha costruito. Personalmente ho sempre avuto un rapporto forte con Roma, che non ho mai abbandonato. Ricordo che Basaglia mi chiamò a Trieste: arrivai fino a Venezia, dormii lì una notte e ritornai indietro. Mi chiesero di dirigere l’Istituto Italiano di Cultura a New York: rifiutai. Oggi Roma è molto degradata, ma quando passo davanti alle rovine sul Palatino viste dal Circo Massimo mi sembra la città più bella del mondo.
Quanto è importante il passato per immaginare e costruire il futuro? Credi che il futuro possa avere un cuore antico?
Nella mia esperienza di psicoanalista mi viene in mente la metafora utilizzata da Freud legata all’archeologia, che procede a degli scavi dagli strati superiori della mente a quelli inferiori. In realtà credo che questi strati siano intrecciati e sovrapposti: più che le pagine di Proust in cui rievoca i ricordi del passato, quasi fossero archiviati in un cassetto, mi sembrano più adeguate le teorie di Gerald Edelman, secondo cui ogni volta che si ricorda si modifica il tessuto del ricordo.
Quali consigli daresti a un giovane che voglia intraprendere la vostra strada?
Sono medico e il corpo mi sta a cuore: il rischio che si può correre oggi è considerare la mente in maniera disincarnata e idealistica, mentre credo sia importante capire come il corpo si rapporta e interagisce con la mente. Si da sempre più spazio alla neurobiologia ma non altrettanta al corpo: dobbiamo ricordare che, se vogliamo capire qualcosa della nostra identità, occorre considerare entrambi con la stessa importanza.
In un’epoca definita della post-verità, ha ancora importanza e forza il concetto di sacro?
Il sacro è importante. Mi riferisco a una dimensione che va al di là del qui e ora, non tanto la religione ma il superamento della materialità quotidiana, con un atteggiamento di rispetto e reverenza verso il soprannaturale. Tra il mondo della concretezza e quello spirituale c’è la stessa distanza della quale parla il poeta inglese Wystan Hugh Auden, “un golfo che nessun ponte potrà mai unire”. Ripenso a una cosa che scrisse il glottologo Giorgio Cardona, che parlava di linguaggio dell’interiorità: “La preghiera interiore, che ti mette a contatto con il senso del sacro”.
Come immagini il futuro? Sapresti darci tre idee che secondo te guideranno i prossimi anni?
È chiaro che stiamo assistendo alla supremazia della teknè, che sembra travolgere tutto, modificando il comportamento umano. I nativi digitali hanno un modo diverso di vedere se stessi e gli altri. È importante rendersi conto di questa mutazione, anche perché negli ultimi anni la velocità della teknè è molto maggiore rispetto alla nostra capacità di adattamento. Si rischia una tecnocrazia che imporrà le sue regole: dobbiamo porci il problema e non rinunciare al senso della dignità umana e a un’etica che possa salvaguardare i nodi fondamentali della vita umana. Potremmo vivere duecento anni e impiantare microchip nel cervello, ma è giusto farlo?
– Ludovico Pratesi

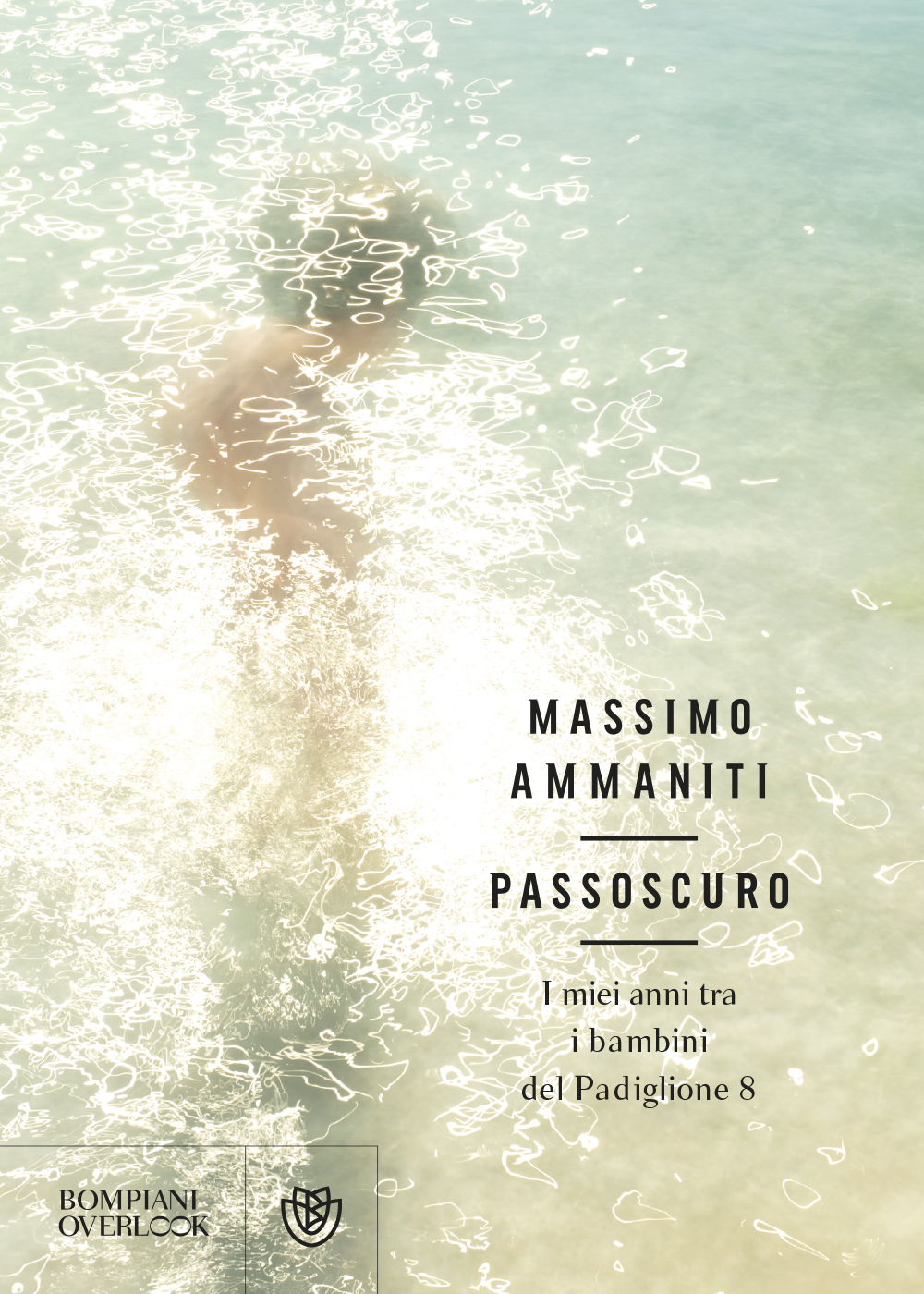


Molto bella questa intervista a Massimo Ammaniti. Viene voglia di leggere i suoi libri.