Giancarlo Consonni
Il viandante stupefatto. Note sulla poesia di Vittorio Sereni
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1419/77872
- 1. Paesaggio con figura
INVERNO
………………………….
ma se ti volgi e guardi
nubi nel grigio
esprimono le fonti dietro te,
le montagne nel ghiaccio s’inazzurrano.
Opaca un’onda mormorò
chiamandoti: ma ferma – ora
nel ghiaccio s’increspò
poi che ti volgi
e guardi
la svelata bellezza dell’inverno.
Armoniosi aspetti sorgono
in fissità, nel gelo: ed hai
un gesto vago
come di fronte a chi ti sorridesse
di sotto un lago di calma,
mentre ulula il tuo battello lontano
laggiù, dove s’addensano le nebbie.
Frontiera, Corrente Edizioni, Milano 1941
Inverno è stata scritta nel dicembre 1934, a 21 anni. Non a caso fa da incipit a Frontiera. È probabilmente uno dei primi componimenti di Vittorio Sereni ed è, a suo modo, una poesia-manifesto: in filigrana vi si può leggere una presa di posizione sul modo e il senso del fare poesia.
L’inizio è leopardiano: «ma se ti volgi e guardi»; così come leopardiano è il situarsi in un paesaggio concreto (Luino tra monte e lago, le fonti alle spalle, il lago davanti). Viene in evidenza l’attivazione di un doppio sguardo: da dentro e da fuori. O, se si vuole, il coesistere di immedesimazione e presa di distanza che fanno del poeta un attore; nel senso che, nel prendere la parola, il poeta presta se stesso alla rappresentazione di una situazione/condizione che va oltre quella personale. In più, la collocazione dell’io parlante in quel particolare paesaggio corrisponde alla messa in scena dello stare su una soglia, dove il fluire (sottinteso) delle acque da monte a lago si fa metafora dello stare nel tempo.
Nel fluire interviene una rottura, rimarcata anche dal brusco passaggio dal presente («ti volgi e guardi») al passato remoto («mormorò… s’increspò»): «Opaca un’onda mormorò/ chiamandoti: ma ferma – ora/ nel ghiaccio s’increspò». Il subitaneo ritorno al presente (con la ripresa dell’incipit «poi che ti volgi/ e guardi») affida nuovamente il flusso del dire al trascorrere del tempo, come se la parola si lasciasse portare dalla sua corrente; ma la rottura che si è consumata serve ad anticipare e a dare forza a ciò che insorge: «la svelata bellezza dell’inverno». La meraviglia si genera d’un tratto: e con essa l’apparire come pienezza, il bello come rivelazione.
Segue un commento: «Armoniosi aspetti sorgono/ in fissità, nel gelo». L’annotazione è forse di troppo ma risponde a un’intenzione: affermare che la bellezza si dà «in fissità», come sospensione del tempo.
La sospensione è in realtà un lievitare: l’e-motus suscitato dal rivelarsi della bellezza. Quanto è vissuto interiormente si fa visibile (ecco lo sguardo da fuori): straborda in un cenno di stupore del poeta attore: un «gesto vago», dove «vago» sta, credo, per appena accennato e comunque appropriato a una recitazione che si proponga di mettere in scena quel particolare accadimento: l’emozione che si può provare «di fronte a chi ti sorridesse/ di sotto un lago di calma».
Nell’incanto irrompe un suono – «ulula il tuo battello lontano/ laggiù, dove s’addensano le nebbie» –, dove quel «tuo» – «il tuo battello» – interviene come un richiamo alla realtà. Chi ha preso la parola – il poeta – sa che la sua vita è destinata a svolgersi altrove, fuori dallo spazio materno di Luino: nella direzione presa dal battello che si perde nelle nebbie: verso Milano.
Ma, come sempre in Sereni, il senso fuoriesce dalla contingenza autobiografica per farsi generale. La vita non può essere mantenuta in quella emozione/sospensione: al suo culmine lo stato di grazia è incrinato dalla consapevolezza di essere momentaneo: tutto fugge e la condizione degli umani è quella di vivere nell’assenza della pienezza; o, detto altrimenti, nell’esclusione da un paradiso in cui per qualche attimo ci è stato dato di vivere.
Entrano dunque in campo un qui e un altrove. Il qui è lo stato di felicità: la sensazione di una piena appartenenza al cosmo. L’altrove sereniano è fatto di contrasti: da un lato è ciò che ci manca, il luogo del desiderio; dall’altro è l’insieme di necessità, di obblighi e di circostanze in cui siamo stati gettati o in cui abbiamo finito per infilarci: il luogo del nostro dissiparci, del vivere giorno per giorno la condizione di mortali. La vita è lo spiazzamento da un centro dove è impossibile permanere: andiamo raminghi, anche se il ricordo dello stato di grazia non ci lascia e a quello vorremmo ritornare. Si ha così il contrasto tra una travolgente fame di vita e l’apparire della vita stessa come una dissipazione in cui dolore e stupore convivono[1].
Viene in mente Virgilio (Georgiche III, vv. 284-285):
Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus,
singula dum capti circumvectamur amore.
Ma fugge intanto, fugge e non ritorna il tempo,
mentre presi d’amore andiamo di cosa in cosa.
Ma anche le «colombe dal disio chiamate» dell’episodio di Paolo e Francesca del V libro dell’Inferno.
Ho detto che «Inverno» è per certi versi una poesia-manifesto. La lettera che a meno di un anno di distanza, il 3 novembre 1935, Sereni indirizza a Luciano Anceschi attesta come, fin dai primi passi, il farsi della sua poesia fosse sorretto da una chiarezza di intenti e da una straordinaria consapevolezza sui modi:
Con accostamenti e rapporti arbitrari tentare di attribuire autonomia all’immagine; di modo che lo svolgersi dell’una nell’altra, colto in una determinata misura e intensità, basti da solo a creare l’emozione; senza lirici commenti e senza intenzioni di sensi nascosti come troppo spesso mi succedeva una volta. Poi si sono cambiati anche gli oggetti del mio mondo; tendo a rendere i termini concreti il più possibile: mi sono abituato a considerare la poesia come approfondimento di momenti che nel romanzo rimangono necessariamente sommari[2].
La corrispondenza fra il dire e il fare è notevole; e non solo per quanto il poeta andava scrivendo in quel periodo ma per quanto scriverà in seguito. Forse non corrisponde al vero la dichiarazione di un operare «senza intenzioni di sensi nascosti come troppo spesso mi succedeva una volta»; ma il cuore del discorso sta nell’intenzione dichiarata di volersi attenere a «un’immediatezza oggettiva». L’affidarsi a «termini concreti» evitando «lirici commenti» punta sul generarsi dell’emozione dalle cose e dalle situazioni.
2. Arte della fuga e sospensione. Il contrasto come motore di senso
L’esperienza di vita e quella che è avvertita come condizione esistenziale sollecitano uno specifico modo espressivo che fin da subito, in Sereni, si fa voce inconfondibile.
Lo «svolgersi» di un’immagine nell’altra e gli accostamenti arditi sono elementi ricorrenti nella sua scrittura. «La bellezza, la poesia – affermerà in una conversazione con Ezra Pound per Radio Monteceneneri forse del 1955 – accostano le cose più lontane e più disparate»[3]. In molti tratti il poiein sereniano assume il carattere di un vagabondare insaziabile: «Io batto le strade» (Nebbia, Frontiera), a inseguire «il concerto della vita che svaria» (Concerto in giardino, Frontiera). Un peregrinare che lo stesso poeta, dopo l’esperienza della guerra, non saprà più «se di rincorsa o fuga» (Il male d’Africa, Diario d’Algeria), incalzato come sarà da ciò che è andato perduto o che percepisce come occasione mancata: «Ogni strada t’insegue» (Ritorno, Frontiera).
Il nomadismo esistenziale trova espressione in una personale declinazione dell’arte della fuga, modalità che connota in varia misura l’intera produzione poetica di Sereni e che è praticata in uno con un’arte del vedere apparentata con la tecnica cinematografica, come l’uso di un modo di rappresentare i paesaggi che richiamano il piano sequenza. Mi limito a quattro esempi, accoppiati a due a due, in cui si ha la restituzione di due diversi paesaggi: quello delle Prealpi lombarde e dei laghi e quello di Milano e del suo territorio.
Nel primo caso la fuga appare come un planare dai rilievi prealpini verso le acque lacustri:
Tu sai che la strada se discende
ci protende altri prati, altri paesi,
altre vele sui laghi […].
(Strada di Creva, Frontiera)
In me il tuo solo ricordo è un fruscìo
solo di velocipedi che vanno
quietamente là dove l’altezza
del meriggio discende
al più fiammante vespero
tra cancelli e case
e sospirosi declivi
di finestre riaperte all’estate.
(In me il tuo ricordo, Frontiera)
Nel secondo caso a essere protagonista è il percorso dall’interno della città (Milano) alla campagna, con campi lunghi che si perdono nella pianura:
[…] dove la città
in un volo di ponti e di viali
si getta alla campagna […]
(3 dicembre, Frontiera)
E noi ci si sente lombardi
e noi si pensa
a migrazioni per campi
nell’ombra dei sottopassaggi.
(Canzone lombarda, Frontiera)
La tensione del poiein sereniano a farsi «infinita navigazione» (La strada di Zenna, Frontiera) è consunstanziale alla fame di esperienza e di conoscenza e all’aspirazione assillante a una vita autenticamente e pienamente vissuta. Da qui la messa in scena di un incessante trasmigrare, dove l’inquietudine – «Inquieto nella tradotta/ che ti sfiora» (Città di notte, Diario d’Algeria) – si accompagna al dolore, talora squarciato da lampi di felicità.
Convivono, nel dolore, una parte in luce e una parte oscura. Tra le ragioni esplicite un posto rilevante spetta alla tragedia della guerra che ha mandato al massacro la meglio gioventù e ha rubato la giovinezza a chi è sopravvissuto:
Prima sera d’Atene, esteso addio
dei convogli che filano ai suoi lembi
colmi di strazio nel lungo semibuio.
(Italiano in Grecia, Diario d’Algeria).
Nella parte oscura agisce un «disperato murmure» (Diario bolognese, Diario d’Algeria) che, nell’incedere del dire, assume la funzione che ha il basso continuo in musica. Un «murmure» che «sfiora la nostra vita» (Terrazza, Frontiera) e che, in diversi passaggi, in particolare in Frontiera, vede, non casualmente, il suono precedere l’immagine (altra modalità espressiva che appartiene al linguaggio cinematografico con cui la poesia di Sereni ha non poche affinità):
– «un bisbiglio di gente per le strade» (Inverno a Luino, Frontiera);
– «un assiduo rumore/ di fabbriche fonde, di magli» (Nebbia, Frontiera);
– il «rombo degli autocarri che mordono la montagna» (Soldati a Urbino, Frontiera);
– il «passo dei notturni battaglioni» (Poesia militare, Frontiera);
– «quei passi che salivano alla morte/ indrappellati» (Nel sonno, Gli strumenti umani);
– «un fioco tumulto di lontane/ locomotive verso la frontiera» (Inverno a Luino, Frontiera);
– gli «echi delle cacce che ti sfiorano» (3 dicembre, Frontiera).
Si potrebbe continuare. Il «murmure» chiama in causa diverse ragioni di senso, talora compresenti:
– il passare del tempo e delle generazioni come un’«oscura […] folla che trascorre all’ombra fedele dei morti» (Paese, Frontiera);
– la consapevolezza che ogni giorno una parte di noi va perduta: «Di noi cosa fugge sul filo della corrente?» (Gli squali, Gli strumenti umani): «Solo, di me, distante/ dura un lamento di treni,/ d’anime che se ne vanno» (In me il tuo ricordo, Frontiera);
– fino alla constatazione della vanità del tutto: «il concerto della vita/ che svaria in estreme girandole d’acqua» (Concerto in giardino, Frontiera).
Ma il «murmure» convoca sulla pagina anche «l’opaca trafila delle cose» (Ancora sulla strada di Zenna, Gli strumenti umani): da un lato il mistero impenetrabile che avvolge il mondo e dall’altro l’assillo per l’incapacità di impedire quello che il poeta percepisce come un’immane dilapidazione: il fluire della vita, la propria e quella degli altri, privo di una pienezza di senso, orfano di grazia e bellezza. In un’intervista rilasciata a Gian Carlo Ferretti e pubblicata su «Rinascita» il 24 ottobre 1980 Sereni, parlando di Stella Variabile che sarebbe uscito di lì a poco, dirà delle condizioni e di ciò che muove il suo fare poesia:
dovrebbe esprimere quella presenza di impotenza e potenzialità, la mia difficoltà a capire il mondo in cui viviamo e al tempo stesso l’impulso a cercarvi nuovi e nascosti significati, la coscienza di una condizione dimidiata e infelice e l’ipotesi di una vita diversa, tanto vaga e sfuggente oggi quanto pronta a riproporsi ogni volta che se ne sappiano cogliere gli indizi e le tracce umane. È il mio modo, in fondo, di vivere la crisi[4].
Parole di rara lucidità che possono gettare una qualche luce sulla sua poesia, in particolare il giustapporsi in essa di orizzontale e verticale: l’irrompere nel «murmure» di rotture: innesti fulminanti che sembrano rispondere alla volontà di restare vigili nella veglia. È come se il poeta volesse scuotere se stesso e il lettore dalla tentazione di arrendersi al corso delle cose e di rassegnarsi alla perdita di senso. Due esempi:
– «s’avventano rondini in volo/ perdutamente» (Alla giovinezza, Frontiera), dove più che mai il poiein si identifica con quell’avventarsi e con quel «perdutamente»;
– «sul grido/ dei viali mi sporgo» (Finestra, Gli strumenti umani).
Precipizio e urlo. Ma non sono solo questi i modi di praticare la rivolta. C’è anche lo «svolto» (lo svoltare improvviso):
S’illumina a uno svolto un effimero sole,
un cespo di mimose
nella bianchissima nebbia.
(Nebbia, Frontiera)
E c’è il contrasto di movimento e quiete; dove, ancora una volta, la giustapposizione si fa motore di senso:
filano treni a sud-est
tra campi di rose.
(Concerto in giardino, Frontiera).
Siamo tutti sospesi
a un tacito evento questa sera
entro quel raggio di torpediniera
che ci scruta poi gira se ne va.
(Terrazza, Frontiera)
Il contrappunto si spinge fino allo schiudersi di momenti d’incanto: il «cespo di mimose» prima citato; il «silenzio stupito» (Strada di Zenna, Frontiera); o, ancora, «una luce di calma»: «nel buio di una piazza/ una luce di calma, una vetrina» (Inverno a Luino, Frontiera).
Ma ancor più efficace è la messa in scena dell’attesa che precede l’incanto. Mi riferisco in particolare alla poesia «Via Scarlatti» posta all’inizio de Gli strumenti umani:
VIA SCARLATTI
Con non altri che te
è il colloquio.
Non lunga tra due golfi di clamore
va, tutta case, la via;
ma l’apre d’un tratto uno squarcio
ove irrompono sparuti
monelli e forse il sole a primavera.
Adesso dentro lei par sempre sera.
Oltre anche più s’abbuia,
è cenere e fumo la via.
Ma i volti i volti non so dire:
ombra più ombra di fatica e d’ira.
A quella pena irride
uno scatto di tacchi adolescenti
l’improvviso sgolarsi d’un duetto
d’opera accorso a un capannello.
E qui t’aspetto.
Gli strumenti umani, Einaudi, Torino 1965
Dopo essere stata introdotta da «Con non altri che te/ è il colloquio» ed essersi distesa per 14 versi a parlare della vita di via Scarlatti in un giorno qualsiasi – un succedersi di casualità e consuetudini –, la poesia si conclude bruscamente con quel «E qui t’aspetto». Una chiusa concentratissima e, allo stesso tempo, in sordina; e per questo ancor più incisiva: un modo quanto mai efficace per dire del sovvertimento che l’amore, soprattutto nella sua fase aurorale, porta nella vita delle persone. Non è che uno dei modi adottati dal poeta per far intendere come nella vita e nella poesia ordinario e sublime possano coesistere e illuminarsi a vicenda.
La concordia discors fra narratività distesa e addensamenti inaspettati – fra dissipazione e concentrazione – è uno dei tratti distintivi della poesia di Sereni. Se la dissipazione sembra rispondere a un profondo sentimento di pietas – l’anelito a inseguire/patire le cose e i destini, a cui ho già accennato –, la concentrazione risponde a un’istanza potente di rigore etico.
Riserbo e parsimonia possono forse spiegare perché, in questa poesia, siano rari i momenti in cui trovano spazio stupore e incanto. Una chiave ulteriore, quasi una giustificazione, ci è offerta dallo stesso poeta nel verso «la gioia quando c’è basta a sé sola» (Le ceneri, Gli strumenti umani). Ma discutere di questo ci porterebbe troppo lontano. Mi limito a osservare che, se la poesia di Sereni ha altre urgenze che non dare conto della gioia, in una scrittura come la sua, dove il contrasto ha un ruolo cardinale, stupore e incanto intervengono dove e quanto è necessario.
Si palesa, alla fine, un modo di concepire lo stesso fare/farsi della poesia: la tensione a tenere insieme alto e basso, luce e ombra, lampi di verità e mistero. E, appunto, ordinario e sublime.
3. «Questo trepido vivere nei morti»
Se l’esperienza personale non può che essere il motore primo di ogni fare artistico, l’andare oltre l’io è, credo, una delle condizioni perché si dia poesia. Sereni ne ha fin da subito piena consapevolezza. Non che il poeta non parli di sé; anzi. Solo che lo fa con una capacità di guardarsi da fuori che rasenta la spietatezza. Ne «Le sei del mattino» (Gli strumenti umani) il poeta arriva a toccare l’estremo raffigurandosi da morto:
LE SEI DEL MATTINO
Tutto, si sa, la morte dissigilla.
E infatti, tornavo,
malchiusa era la porta
appena accostato il battente.
E spento infatti ero da poco,
disfatto in poche ore.
Ma quello vidi che certo
non vedono i defunti:
la casa visitata dalla mia fresca morte,
solo un poco smarrita
calda ancora di me che più non ero,
spezzata la sbarra
inane il chiavistello
e grande un’aria e popolosa attorno
a me piccino nella morte,
i corsi l’uno dopo l’altro desti
di Milano dentro tutto quel vento.
In «Notturno» (Stella Variabile), invece, mette in scena la presa di coscienza della assoluta irrilevanza della propria – e insieme della nostra – presenza nell’universo:
NOTTURNO
Confabula di te laggiù qualcuno:
l’ineluttabile a distesa
dei grilli e la stellata
prateria delle tenebre.
Non ti vuole ti espatria
si libera di te
rifiuto dei rifiuti
la maestà della notte.
(Stella variabile, Garzanti, Milano 1981)
C’è poi la consapevolezza della propria estraneità al mondo che è venuto avanti, come nella V parte della poesia «Nel sonno» (Gli strumenti umani):
L’Italia, una sterminata domenica.
Le motorette portano l’estate
il malumore della festa finita.
Sfrecciò vano, ora è poco, l’ultimo pallone
e si perse: ma già
sfavilla la ruota vittoriosa.
E dopo, che fare delle domeniche?
Aizzare il cane, provocare il matto…
Non lo amo il mio tempo, non lo amo.
L’Italia dormirà con me.
In un giardino d’Emilia o Lombardia
sempre c’è uno come me
in sospetti e pensieri di colpa
tra il canto di un usignolo
e una spalliera di rose…
In questa direzione va la rappresentazione di se stesso nella condizione di straniero rispetto alla vita metropolitana e al moto ripetuto che la caratterizza:
rumore che si somma a rumore e presto spavento per me
straniero al grande moto e da questo agganciato.
(Una visita in fabbrica (1952-58), Gli strumenti umani)
O, ancora, la rappresentazione di sé come esule non solo nei luoghi in cui è vissuto un tempo ma in quelli stessi in cui vive. Nella parte conclusiva della VI parte de «Nel sonno», già citata, abbiamo una penetrante restituzione della condizione metropolitana:
Ma sì, quella sfilata di tetti
quei balconi e terrazze
rapido ponte tra noi ogni mattina
e a sera lenta fuga…
già domani potresti abbandonarti
a un’altra onda di traffico, tentare
un diverso versante,
mutare gente e rione
e me su uno
di questi crolli del cuore, di queste repentine
radure di città lasciare
con l’amaro di una perdita
con quei passi di loro tardi uditi.
Solitudine, solo orgoglio…
Geme
da loro in noi nascosta una ferita
e le dà voce il vento dalla pianura,
l’impietra nelle lapidi.
Ma, al di là di questi casi espliciti, certamente significativi, è l’intera poesia di Sereni a essere permeata dalla tensione a superare il riferimento alla propria persona anche quando parla esplicitamente di fatti personali. Si torna al nodo immedesimazione/ presa di distanza che gli attori ben conoscono. Un procedimento di cui Sereni sembra dare conto in questo passaggio di una poesia dedicata ad Attilio Bertolucci.
In dormiveglia di là da quella porta.
Succede. Qualche volta.
Che a me un altro di me parli
fin dentro me.
(A Parma con A. B., Stella variabile)
Ma, come nei grandi attori, non si tratta solo di una “tecnica”. In Sereni, la tensione all’ascolto del mondo e della vicenda umana, oltre che configurarsi come un patire, assume anche i caratteri di un perdersi, di un naufragare nel mare delle generazioni, dove il destino personale non è che uno dei tanti. La dice lunga l’uso dell’espressione «io noi» nella poesia «Il piatto piange» (Gli strumenti umani).
Tensione etica, pietas e ribellione si intrecciano al punto che la poesia si porta assai vicino al silenzio/voce dei morti, o anche a un dire oltre la morte. «Questo trepido vivere nei morti» è un verso che introduce la seconda parte della poesia «Strada di Creva» (Frontiera). Vi si può leggere in controluce la precoce consapevolezza sulla condizione in cui dà il fare poesia.
Quella dei morti è per Sereni un’«ombra fedele» (Paese, Frontiera): una presenza a cui egli contrappone in qualche modo quella dei vivi-morti «persi per sempre murati in un lavoro/ dentro scroscianti città» (Il piatto piange, Gli strumenti umani). Anche se, vent’anni dopo l’uscita di Frontiera, il16 dicembre 1961, in una lettera a Mario Boselli, il poeta scriverà: «Inconcludente concordia coi morti, insufficiente riscatto dell’estraneità, difficoltà a “legare” coi vivi»[5].
Tra la «città selvosa» e la necropoli
Oltre al paesaggio di Luino e a quello di Bocca di Magra, un tòpos della poesia di Sereni sono le città, Milano ma non solo. I nuovi paesaggi urbani e metropolitani sono per il poeta motivo di disorientamento e di dolore. Appare chiaro come la pensi ove si confronti il verso «le città etichette di valigie fiammelle di necropoli» (Metropoli, Gli strumenti umani) con questi altri: «O mia vita mia vita ancora ansiosa/ d’un urbano decoro…» (Risalendo l’Arno da Pisa, Diario d’Algeria).
Se da un lato c’è la «città selvosa» (Un visita in fabbrica, Gli strumenti umani) – nel senso che promette ricchezza di esperienza e avventure conoscitive a chi la sa vivere e esplorare – dall’altro c’è la «città di cenere» (La pietà ingiusta, Gli strumenti umani).
Sui guasti della città in vario modo violentata, in guerra e in pace, si possono richiamare questi versi della poesia «Revival» (Stella variabile) che sembrano restituire molto delle lacerazioni nei paesaggi urbani che sono venuti avanti anche dopo, in questi ultimi decenni:
Tra quanto resta di macerie
e tutta questa costruenda roba
in vetrocemento acciaio
bel posto per riunioni e incontri.
E grinte e sarcasmi da finestre a finestre
che non danno su niente
da facciate minacciate di crollo
da facciate che non hanno dietro niente
mi sbalzano
di venti anni all’indietro
in una piazza di Venezia
sull’aria saltellante del Terzo uomo –
come di attimi a ritroso nel replay
scavalla lo spettro televisivo – …
ecco che torna
la pioggia
fredda sulla guerra fredda, la faccia
per pochi istanti allora amata
presto tagliata via
dietro un sipario di lacrime.
A contrasto, si possono leggere gli splendidi ritratti di due città: Amsterdam e Venezia:
DALL’OLANDA
Amsterdam
A portarmi fu il caso tra le nove
e le dieci d’una domenica mattina
svoltando a un ponte, uno dei tanti, a destra
lungo il semigelo di un canale. E non
questa è la casa, ma soltanto
– mille volte già vista –
sul cartello dimesso: «Casa di Anna Frank».
Disse più tardi il mio compagno: quella
di Anna Frank non dev’essere, non è
privilegiata memoria. Ce ne furono tanti
che crollarono per sola fame
senza il tempo di scriverlo.
Lei, è vero, lo scrisse.
Ma a ogni svolta a ogni ponte lungo ogni canale
continuavo a cercarla senza trovarla più
ritrovandola sempre.
Per questo è una e insondabile Amsterdam
nei suoi tre quattro variabili elementi
che fonde in tante unità ricorrenti, nei suoi
tre quattro fradici o acerbi colori
che quanto è grande il suo spazio perpetua,
anima che s’irraggia ferma e limpida
su migliaia di altri volti, germe
dovunque e germoglio di Anna Frank.
Per questo è suii suoi canali vertiginosa Amsterdam.
(Gli strumenti umani)
A VENEZIA CON BIASION
O God, what great kindness
have we done in time past
O God of the night
what great sorrow
Cometh unto us..
Ezra Pound
Quale nostro passato valore
dimenticato presto
ci meritava il dono di Venezia
della sua meraviglia?
Di quale gran dolore
che tuttora ci aspetta
ci risarciva anzitempo Venezia?
A tali domande non rispondono più
il dio delle acque il dio della notte.
Sprofondano con le città
sotto il nostro orizzonte.
Col male di una domanda non fatta
di una risposta non giunta si va
su acque in perpetuo turbate:
su slontananti acque nere, una notte,
una nostra Venezia congetturando tra quelle luci rade.
Ma viene con le sue conchiglie
col suo sasso marino
il sempreragazzo il tuttoterrestre Biasion.
A sostentare capitelli, a spaziare gabbiani.
Non ama – si dice – in verticale
spendersi, ma questo
è poi vero? Svetta
su profili slabbrati
su tramontanti cupole e cuspidi
la spiga del suo pane solare.
(Stella Variabile)
[1] In una lettera a Giancarlo Buzzi del primo marzo del 1961 (ora in «Concertino», Bimestrale di varia cultura, a. I, n. 1, giugno1992, pp. 42-43) Sereni scrive: «Tu hai visto molto bene la contraddizione tra una tristezza (privata e non privata, più privata che no) di fondo e la vivezza, anche paesistica, che m’illudo d’aver messo in quanto ho scritto». Vittorio Sereni, Poesie, Edizione critica a cura di Dante Isella, Mondadori, Milano 1995, p. 480.
[2] Lettera di Vittorio Sereni a Luciano Anceschi del 3 novembre 1935, in Sereni, Poesie, cit., p. 291.
[3] Sereni, Poesie, cit., p. 505-506.
[4] Conversazione con Vittorio Sereni, sul presente e sul passato, sul suo lavoro. Questo scrivere così vacuo così vitale, a cura di Gian Carlo Ferretti in «Rinascita», a. 37, n. 42, 24 ottobre 1980, p. 40, cit. in Sereni, Poesie, cit., p. 664.
[5] La lettera, ora in Sereni, Poesie, cit., pp. 542-3, è stata pubblicata in «Nuova Corrente», n. 25, gennaio-marzo 1962, pp. 7-9.


Giancarlo Consonni (Merate, 14 gennaio 1943) è un poeta, urbanista e storico dell’architettura italiano.
https://it.wikipedia.org/wiki/Giancarl

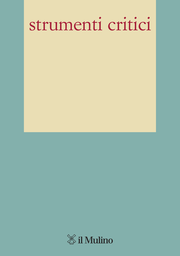

Bellissimi alcuni versi di queste poesie di Sereni.