
LATERZA, 2022
DALL’ESTRATTO OFFERTO DALL’EDITORE
Introduzione
La pandemia – evento inatteso che ha fatto irruzione due anni fa nelle vite di tutti – ha messo in luce con durezza la radicale fragilità della nostra condizione umana. I dati sono impressionanti: più di cinque milioni di morti nel mondo. E ad essere colpiti sono stati i più fragili. La pandemia – si può dire – ha toccato con precisione chirurgica tutte le nostre fragilità. Quelle personali e quelle istituzionali. Il Covid-19 ha messo a nudo il fatto che, dietro lo scintillio delle sue tante conquiste, la verità della nostra società avanzata è un po’ diversa da quella che sono (e siamo) soliti raccontare. Papa Francesco, in piena pandemia, in piazza San Pietro, ha detto: «Siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre siamo in mare agitato, ti imploriamo: svegliati, Signore!».
Rispetto a un passato nemmeno troppo lontano viviamo di più e meglio. E questa è una gran bella cosa. Ma contemporaneamente aumenta il numero delle persone vulnerabili. È uno dei paradossi del nostro tempo. Dal punto di vista sanitario, nel passato la selezione naturale faceva il suo corso e i malati, i deboli, morivano prima. Ora, per fortuna, riusciamo a combattere molte malattie, a gestire la cronicità di tante patologie. Ma il paradosso della potenza è che necessariamente ci fa convivere con un diffuso indebolimento, che è, per così dire, il costo dei successi ottenuti: le persone «risanate» dalle diverse malattie da cui sono state colpite vivono più a lungo, ma non per questo viene cancellata la loro (nostra) radicale fragilità.
Forse su questo risvolto dovremmo riflettere di più: mentre riusciamo a salvare vite, a curare malattie, a sostituire gli organi che non funzionano, sognando una società di persone in perfetta salute e magari, chissà, un giorno immortali (c’è chi azzarda anche questo!), la realtà della condizione contemporanea, che la stessa potenza crea, è ben diversa. Nella sofferenza e nella morte di un enorme numero di persone abbiamo imparato la lezione della fragilità. Ce lo ricordano le migliaia e migliaia di anziani che sono morti per il Covid-19. Lo sanno bene gli innumerevoli disabili dimenticati durante la pandemia, come anche i bambini, che in questi lunghi mesi non hanno ricevuto quanto era loro necessario per la crescita. In numerosi paesi gli ospedali hanno fatto fatica a soddisfare le innumerevoli richieste di ricovero, costringendo anche al razionamento e alla sovraesposizione del personale assistenziale. Una miseria immensa, indescrivibile! La lotta per il bisogno primario di sopravvivenza ha messo in evidenza la condizione di coloro che vivono in uno stato di povertà estrema ai margini della società, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, e degli abbandonati destinati all’oblio nell’inferno dei campi profughi.
Abbiamo toccato con mano il volto più tragico della morte: alcuni hanno conosciuto la solitudine della separazione, sia fisica che spirituale, hanno lasciato le proprie famiglie impotenti, impossibilitate ad accomiatarsi dai loro cari, senza neanche la possibilità della più elementare pietà di una sepoltura adeguata. Abbiamo visto vite finire senza alcuna distinzione di età, status sociale o condizioni di salute.
«Fragili». Ecco cosa siamo tutti: radicalmente segnati dall’esperienza della finitudine che è al cuore della nostra esistenza; non si trova lì per caso, sfiorandoci con il tocco gentile di una presenza transitoria, lasciandoci vivere indisturbati, nella convinzione che tutto andrà secondo i piani. Tutti noi umani affioriamo da una notte dalle origini misteriose: chiamati a essere oltre ogni scelta, presto arriviamo alla presunzione e alle lamentele, rivendicando come nostro quello che ci è stato solamente concesso. Troppo tardi abbiamo imparato ad accettare il mistero da cui veniamo e a cui, infine, torneremo. Il mistero dell’esistenza ci avvolge.
Secondo alcuni la pandemia non lascerà cambiamenti significativi. Tutto finirà nel nulla, dicono i pessimisti (loro si pensano realisti). La vita va e viene, dice il custode della prudenza cinica. Ma questo suo crescere e decrescere, ora reso più evidente dalla fragilità della nostra condizione umana, potrebbe aprirci a una diversa saggezza, ad una nuova consapevolezza. La dolorosa prova della fragilità della vita può anche rinnovare la coscienza che essa è comunque un dono. Un dono che ci è stato dato, per nulla richiesto. Così ci appare fin dall’inizio: tutti riceviamo la vita dai genitori. L’ombelico, quella cicatrice che tutti abbiamo, ci ricorda l’incancellabile dipendenza: c’è una ferita originaria che racconta la nostra dipendenza radicale. Cresciamo, ci irrobustiamo, creiamo cose belle e nuove, sempre, però, restiamo figli. Nessuno autonasce, nessuno si autogenera.
L’essere figli è l’archetipo anche della nostra fragilità, scrive Eva Feder Kittay nel suo splendido volume La cura dell’amore. Donne, uguaglianza, dipendenza. «Figlio» significa anche dipendenza. Mi chiedo, perciò: non saremmo più saggi se comprendessimo il senso della ineliminabile dipendenza e, quindi, della debolezza che ci contraddistingue? Tutti, alla nascita, eravamo nudi, piangenti e in balia del mondo. Questa radicale dipendenza (o non autosufficienza) potrà essere nascosta, dimenticata, ma mai oltrepassata. Se l’avessimo presente, non saremo più grati e meno arroganti?
La realtà radicale della nostra fragilità è una delle grandi lezioni da apprendere dalla pandemia. Eravamo nel mezzo di un’euforia tecnologica, e siamo stati colpiti letteralmente a morte, anche perché tecnicamente e socialmente impreparati. Giuseppe Curigliano, oncologo milanese, scriveva: «Abbiamo imparato che la scienza del XXI secolo ha avuto un ruolo marginale nel controllo dell’attuale pandemia. È innegabile che l’abbiamo contenuta con le norme del XIX secolo: lavaggio delle mani, confinamento sociale e quarantena» («Corriere della Sera», 20 maggio 2020).
Siamo ancora oggi in affanno, ma è necessario riconoscere la nostra vulnerabilità fisica, culturale e politica di fronte al Covid-19: era, in effetti, impensabile la destabilizzazione esistenziale che ha provocato e che continua a provocare. E gli studiosi ci dicono che dovremo abituarci a convivere con il virus e abbandonare l’idea di una restitutio ad integrum (è praticamente impossibile il ritorno al tempo in cui il virus era assente). È saggio tener in conto la nostra fragilità. In alcune regioni del mondo la fragilità era ed è un’esperienza quotidiana a causa della povertà, che non consente a tutti di accedere a cure pur disponibili o a cibo in quantità sufficiente, che pure a livello mondiale non manca. In altre zone le aree di precarietà sono state progressivamente ridotte dai progressi della scienza e della tecnica, fino a illuderci di essere invulnerabili o di poter trovare una soluzione tecnica per tutto. Una cosa è vera: siamo tutti nella stessa tempesta, ma non tutti sulle stesse barche. Quelle più fragili sono state e continuano ad essere travolte senza alcuna resistenza.
Le nostre ottimistiche proiezioni della potenza scientifica e tecnologica di cui disponiamo ci avevano lasciato immaginare che saremmo stati in grado di prevenire il diffondersi di un’epidemia globale di queste proporzioni. Non è stato così. Al di là di altre considerazioni, appare evidente che non siamo realmente padroni del nostro destino. E anche la scienza continua a mostrare i propri limiti. Ne eravamo già consapevoli: i suoi risultati sono spesso parziali, sia perché si concentra – per convenienza o per ragioni intrinseche – su alcuni aspetti della realtà lasciandone fuori altri, sia per lo statuto stesso delle proprie teorie, che sono comunque provvisorie e rivedibili.
È vero che nell’incertezza che tutti abbiamo vissuto nei lunghi mesi di pandemia abbiamo colto con una nuova chiarezza la gradualità e la complessità richieste dal sapere scientifico, con le sue esigenze di metodo e di accertamento. Precarietà e limiti delle nostre conoscenze appaiono essi pure globali, reali, comuni. Tocchiamo anche con mano quanto strettamente siamo tutti connessi: anzi, nella nostra esposizione alla vulnerabilità siamo più interdipendenti che non nei nostri apparati di efficienza. C’è una lezione da trarre da questo durissimo tempo di emergenza sanitaria: siamo tutti legati gli uni agli altri. E la consapevolezza della comune fragilità deve spingerci a riscoprire l’urgenza di scegliere la via della solidarietà, ossia del prendersi cura gli uni degli altri. L’esempio della mascherina è illuminante: non la indossiamo solo per salvare noi stessi, ma anche gli altri. Insomma, la comune fragilità invita ad una più pronta solidarietà. È una esperienza che gli spiriti più attenti hanno vissuto già in passato. Ma in questo tempo è emersa come una risposta degna di attenzione. La comune debolezza ci ha fatto scoprire il bisogno della solidarietà o, se si vuole, della fraternità. Addolora da questo punto di vista l’atteggiamento di chi ancora si rifiuta di vaccinarsi, mettendo le proprie pur comprensibili paure e i propri dubbi davanti all’esigenza di «agire insieme», di compiere un gesto che ha tanto più valore ed efficacia quanto più è diffuso.
Prendersi cura di qualcosa significa, infatti, essere capaci di attenzione, di preoccupazione, di premura, di interesse. Da questa postura, accanto e dentro la realtà, scaturisce uno sguardo diversamente illuminato: «Ubi amor, ibi oculus», nella pregnante espressione del mistico benedettino Riccardo di San Vittore o «un cuore che vede» di papa Benedetto XVI (in Deus caritas est). In questa prospettiva diventano pensabili e possibili nuovi orizzonti di azione, che nella dicotomia teoria/prassi non sarebbero immaginabili. La cura permette di riconoscersi parte di un intreccio di vincoli e di reciproche connessioni (il «comune»), ma anche di sviluppare attitudini, competenze, capacità altamente personalizzate. In questo modo, essa infrange anche il confine tra pubblico e privato e tra particolare e universale: tutti dualismi ereditati dalla modernità, che determinano il blocco della nostra vita sociale e la sua stagnazione.
Svincolare la cura dalla sfera privata e/o domestica è indispensabile per restituirne il significato sociale ed eleggerla a prassi diffusa, in grado di incidere sugli equilibri complessivi della società. È la memoria della comune condizione di fragilità che costituisce la vera base del legame sociale. Una memoria in grado di mobilitare il nostro lato emotivo e di fornire un fondamento affettivo alla convivenza. Il «fragile» – che Paul Ricoeur definisce «ciò che è perituro per debolezza naturale e ciò che è minacciato dai colpi della violenza storica» – ha il potere di risvegliare il nostro sentimento, di provocare la nostra indignazione, la nostra preoccupazione di fronte a qualcosa che «avvertiamo come deplorevole, insostenibile, inammissibile, ingiustificabile» e che di conseguenza esige la nostra cura.
La cura è indissolubilmente legata alla reciproca responsabilità. Per la filosofa Elena Pulcini non c’è responsabilità se non laddove «noi sentiamo» di essere resi responsabili da qualcuno che, a causa della sua debolezza, confida nel nostro aiuto e ci chiede di farci carico del suo destino. E Hans Jonas, a ragione, parla di «etica della cura» come presupposto per ripensare i fondamenti della solidarietà sociale che nasce dal riconoscimento di un «Noi» più ampio e condiviso, fondato sulla «somiglianza nel dolore e nell’umiliazione».
Non si tratta semplicemente del dover essere o, se si vuole, di un imperativo morale, ma di un «non poter non sentire» (nel linguaggio cristiano si chiama misericordia) il legame con l’altro che ci tocca nella profondità di quella fragilità che ci costituisce come umani e che tutti condividiamo. La sfida oggi è trovare un nuovo punto di equilibrio tra fattori diversi che tuttavia convergono: la persistente fragilità che ci costituisce e che si produce in più anche come effetto della potenza; il bisogno di creare nuove forme di investimento libidico post-consumerista; la crisi del lavoro; la necessità di formare le persone restituendo loro capacità e ingaggiandole in obiettivi di senso in grado di ricostituire appartenenza.
Possiamo riscoprire legami di solidarietà tra di noi, che coinvolgano anche persone lontane o differenti? Possiamo coinvolgerci in un progetto di società di cui facciano parte gli anziani, i poveri, i disabili, gli stranieri, i carcerati, gli ammalati, i quali ricordano a tutti la comune fragilità e l’urgenza della cura vicendevole? In altre parole: possiamo diventare tutti un po’ più giusti, cioè più fraterni, più solidali, aperti agli altri e non ripiegati nella rivendicazione esclusiva dei diritti individuali?
La politica odierna, che ha visto un’ascesa del populismo, è spesso contrassegnata da divisioni e scontri, da una separazione tra «noi» e «loro». Questo la porta ad essere guidata da risentimento e paura. Da rabbia e da violenza. Insomma, è una politica oppositiva: bisogna opporsi all’altro per crescere da sé stessi. Va ripensata la politica, quella basata sul «patto», tesa al «Noi» della famiglia dei popoli. La grande lezione da apprendere dalla pandemia è che nel mondo possiamo sopravvivere solo nell’orizzonte di un nuovo patto sociale tra i popoli. Questa è la via del nostro futuro immediato. E oggi è il tempo per intraprenderla. Come in passato i popoli sono passati dal Noi all’Io, oggi la rotta va invertita: è necessario che noi pensiamo in termini di «Noi», non soltanto di «Io». È la suggestiva tesi che Jonathan Sacks propone per costruire il futuro delle nostre società. Siamo entrati nel secolo XXI scarichi di sogni e di visioni comuni. In questi primi venti anni abbiamo assistito a tragedie che non pensavamo possibili e il futuro che ci aspetta sembra segnato da catastrofi planetarie. È facile essere pessimisti: ci sono ragioni sufficienti per esserlo. Non è, però, una condanna senza appello.
Ci sono altrettante ragioni per sperare in un futuro migliore sia per noi esseri umani che per il mondo che ci ospita. Abbiamo bisogno di avere uno scatto di pensieri e di azioni mentre abbandoniamo ogni cedimento al prometeismo o al narcisismo. Un nuovo futuro è possibile solo se ci incamminiamo verso l’unità della famiglia umana che responsabilmente abita il pianeta come la «casa comune» di tutti, anche di coloro che verranno dopo di noi. E c’è chi auspica una sorta di alleanza fra i vulnerabili di oggi e i vulnerabili di domani per la giustizia del mondo a venire.
1.
Tra Prometeo e Narciso
Tutti fragili
Cominciamo da una definizione: si dice fragile qualcosa che può rompersi al minimo urto (la parola viene dal latino frangere). Il termine «fragilità», in italiano, è uguale sia al singolare che al plurale e indica una condizione generale che si declina in molteplici forme: i nomi sono molti e diversi, ma tutti rinviano alla radicale incompiutezza sia del mondo che dell’umanità. Più che una qualità che alcuni hanno e altri no, la fragilità è un tratto comune a tutti e a tutto. Nulla le sfugge.
È luogo comune considerare fragile il bambino, il disabile, l’ammalato, l’anziano (in certi contesti e in certe culture, anche la donna). In realtà, la fragilità appartiene alla condizione umana in quanto tale. È fragile il nostro corpo nei suoi meccanismi biologici che facilmente si alterano e si rompono. Sono fragili le nostre emozioni e le nostre relazioni che peraltro riempiono di senso la nostra vita. Sono fragili e mutevoli i nostri comportamenti e le nostre abitudini; fragile la ragione che si scontra continuamente con il suo limite oltre il quale si dà solo arroganza. Potente ma fragile il nostro desiderio, che non sempre si compie nel suo soddisfacimento. Gli uomini e le donne continuano a morire. Non siamo né assoluti né compiuti: la comune esperienza ci dice senza tema di equivoci che la vita non è mai pienamente nelle nostre mani. È fragile e facilmente si può rompere. Per questo le cose fragili vanno maneggiate con cura. L’uomo e le sue realizzazioni sono fragili: quanti imperi sono crollati, quante Chiese sono scomparse.
Ma anche la natura è fragile: quanti sconvolgimenti si susseguono nel corso degli anni, quante rovine sono provocate dai disastri naturali. E si potrebbe continuare. La scienza arriva a dirci che la fragilità è una componente ineliminabile anche di quelle realtà materiali che abbiano sempre considerate eterne e immutabili. Una delle ipotesi che si fa sempre più consistente tra gli scienziati è quella che l’universo stesso, qualora il campo di Higgs subisse una particolare transizione, potrebbe crollare di colpo.
La globalizzazione ha allargato la consapevolezza della fragilità e dell’interconnessione di ciascuno con il destino e le vite degli altri esseri umani. Non solo attraverso la potenza di un singolo e macroscopico evento – pensiamo all’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001 –, ma anche attraverso la sempre più rapida e visibile moltiplicazione di eventi catastrofici (virus letali, terrorismo globale, proliferazione nucleare, crisi finanziarie) e la loro globale interdipendenza, che sempre più ci vincola e ci connette in una dimensione comune. Ormai non possiamo non sapere che siamo tutti fragili, dipendenti, mortali, finiti.
Ma la fragilità non riguarda solo la dimensione fisica: la stessa libertà umana ne reca l’impronta. In questo segno di non autosufficienza si annuncia la costitutiva relazionalità che fa della persona umana un figlio ed un fratello bisognoso di essere amato e protetto. Siamo fragili perché aspiriamo ad essere amati, per imparare ad amare noi stessi grazie agli altri che ci amano. Anche se comunemente si è portati a pensare che sia l’amore a rendere fragili, è vero piuttosto il contrario: si è fragili proprio perché possiamo lasciarci amare e diveniamo capaci di rispondere all’amore.
La fragilità non è un accidente da tenere lontano, non è una malattia, da cui guarire. È piuttosto la condizione che caratterizza la comune natura umana: una delle sue strutture portanti. Non si può scappare dalla propria fragilità. Con essa bisogna fare, volenti o nolenti, i conti. Ma non è solo il segno di una debolezza inutile e insensata, da disprezzare se non si riesce a combatterla: nella fragilità si nascondono valori di sensibilità e di delicatezza, di gentilezza estenuata e di dignità, di intuizione dell’indicibile e dell’invisibile che sono nella vita e che consentono di immedesimarci con più facilità e con più passione negli stati d’animo e nelle emozioni, nei modi di essere esistenziali, degli altri da noi. Insomma, può diventare una risorsa, una opportunità. Fragilità, vulnerabilità e sensibilità: tre aree che sconfinano l’una nell’altra.
Fino a prova contraria, la natura umana è quella di nascere e morire nella fragilità. La vita e la morte sono i due limiti ineliminabili entro i quali si gioca l’esistenza umana. L’uomo con la sua abilità può migliorare tutto ciò che accade tra questi confini estremi, ma certo non può cancellarli: la vita si sporge sempre sulla morte, non dipende dall’uomo. Per quanto sia doveroso combattere ogni sorta di male che possa affliggere la nostra esistenza, questa rimane costitutivamente fragile, in tensione tra questi due estremi inseparabili da noi e tra loro.
L’esperienza della pandemia ci dice che la potenza dei nostri mondi non è così invincibile come forse ci eravamo illusi negli ultimi anni. Ha ragione Morin: mentre la follia euforica del transumanesimo sta portando al parossismo il mito della necessità storica del progresso e quello della padronanza da parte dell’uomo non solo della natura, ma anche del suo destino (predicendo che l’uomo accederà all’immortalità e controllerà tutto con l’intelligenza artificiale), noi siamo dei giocatori/giocati, dei possidenti/posseduti, dei potenti/idioti. Potremo magari ritardare la morte per invecchiamento, ma non potremo mai eliminare gli incidenti mortali in cui i nostri corpi saranno spappolati, non potremo mai liberarci dai batteri e dai virus che incessantemente si automodificano per resistere a medicine, antibiotici, antivirali, vaccini.
La fragilità, dunque, va riconosciuta e accolta: è costitutiva dell’umano. Piene di sapienza sono queste parole di Simone Weil: «La nostra carne è fragile: qualsiasi pezzo di materia in movimento può trafiggerla, lacerarla, schiacciarla, oppure inceppare per sempre uno dei suoi congegni interni. La nostra anima è vulnerabile, soggetta a depressioni immotivate, penosamente in balia di ogni genere di cose, e di esseri altrettanto fragili e capricciosi. La nostra persona sociale, da cui dipende quasi il sentimento dell’esistenza, è costantemente e interamente esposta al caso». Queste parole di Simone Weil ci introducono bene al tema della vulnerabilità, una dimensione strettamente legata alla fragilità. Ne parlerò tra poco. È una consapevolezza che, presa sul serio, aiuta a cambiare molti convincimenti e pregiudizi.
L’archeologo americano Ralph Solecki, dopo aver scoperto in Iraq lo scheletro di un uomo neanderthaliano che mostra segni di gravi disabilità, ritiene che la fragilità sia nel cuore stesso dell’evoluzione. La sua esclusione dal gruppo era sentita già da allora insopportabile: se ne son presi cura. Questa scelta, contraria all’utilità dell’evoluzione semplicemente biologica, spinge ad una riflessione più attenta sulla fragilità come fonte di solidarietà.
Certo, non tutti gli oggetti fragili sono preziosi, così come, al contrario, non tutti gli oggetti preziosi sono necessariamente fragili: tra i due estremi, cioè tra una fragilità che sfuma nell’ordine dell’irrilevanza e una preziosità che s’afferma nell’ordine del valore infinito, al riparo da qualsiasi insidia, in mezzo, potremmo ripetere con Pascal, «c’è solo la vita», in cui prezioso e fragile si incontrano in una unicità irripetibile. Sono del vivente, di quel particolare essere vivente in cui coabitano il limite della ferita; il fragile e il prezioso diventano attributi inseparabili: l’aut aut si annuncia come et et, senza essere tuttavia il risultato di una congiunzione accidentale. La fragilità, in particolare, non rappresenta un attributo estrinseco, che pesa in senso avversativo (prezioso ma fragile) né propriamente in senso successivo (prezioso sebbene fragile) assumendo, al contrario, una centralità strategica nell’endiadi, che finisce per capovolgere la relazione: fragile dunque prezioso.
La condizione di fragilità – che pure tentiamo sempre di rifiutare – conferisce all’umano anche una particolare grazia, una sua straordinaria preziosità. Possiamo dire che rappresenta un paradosso. Nella mentalità comune, la fragilità è l’immagine della debolezza e quindi di una condizione negativa, persino dannosa. In realtà, come ho poco prima accennato, nella fragilità si nascondono valori di sensibilità e di delicatezza, di gentilezza e di dignità, di intuizione dell’indicibile e dell’invisibile che sono nella vita e che consentono di immedesimarci con più facilità negli stati d’animo e nelle emozioni degli altri. È sbagliato perciò considerarla solo come un «difetto», una mancanza di completezza. C’è un legame singolare tra fragilità e preziosità a partire dal piano biologico. Pensiamo al cervello: è costituito da circa 100 miliardi di cellule (neuroni) connesse tra di loro, in continuo dialogo. È un insieme fragilissimo e preziosissimo. Così, pure il prendersi cura significa un modo attento di vivere il rapporto con gli altri, fatto appunto di delicatezza e di premura, tanto tali legami sono fragili. È un modo di relazionarsi diverso dal dominio e dal contratto. Prendersi cura significa compromettersi con l’altro, «sopportarlo» nel senso attivo di sollevarlo, di prenderlo in braccio. È il senso di compiere un gesto di eccedenza rispetto alla logica utilitaristica. L’essere umano ha bisogno degli altri, non solo in momenti particolari, ma sempre, per tutto l’arco dell’esistenza, dalla nascita alla morte.
Tutti gli aspetti dell’esistenza creaturale sono segnati dalla fragilità: non solo gli uomini, ma tutte le creature; non solo il corpo, ma anche lo spirito, i pensieri, le parole, i sentimenti. Siamo impastati di fragilità, di polvere, si potrebbe dire, richiamando il racconto biblico della creazione. L’autore sacro per indicare la creazione dell’uomo da parte di Dio usa il termine «plasmare», lo stesso che veniva usato per descrivere l’attività del vasaio che, con arte, crea qualcosa di bello, ma allo stesso tempo fragile. Questa dualità intesse l’intero racconto. Il termine «Adam» etimologicamente significa il «terroso», ma nel quale Dio soffia un alito di vita. E diviene Adam. L’uomo, insomma, è descritto come polvere, terra, indicando così il suo statuto vulnerabile e, contemporaneamente, come alito di Dio per indicarne l’eternità. Fragilità ed eternità, terrestrità e forza divina si articolano in ogni essere umano. E, si badi bene, chi scatena la crisi nel «giardino» della vita non sono l’uomo e la donna ma «il più astuto di tutti gli animali» (Gen 3,1). È il serpente che sollecita i due a non accettare il limite (l’essere «terrosi») ma a cogliere «l’eterno» che è in loro per spodestare Dio. È l’apparire della hybris dell’onnipotenza. Ed è l’obbedienza a tale hybris che li fa scoprire, con amarezza, «nudi» (fragili) e senza più il giardino. Dio comunque non li abbandona, ha compassione di loro e, mentre escono da quel giardino per entrare nella storia, li «veste» perché non sentano il freddo che debbono affrontare.
La fragilità – suggerisce il testo sacro – va accolta e vissuta sensatamente. Solo così se ne coglie la potenzialità, se legata, ovviamente, al mistero di Dio per chi crede o al mistero dell’amore per tutti, anche per chi non crede. Non posso dilungarmi su questo, ma la pagina biblica avverte anche noi, uomini e donne di questo tempo, circondati dall’onnipotenza della tecnica che spinge sino a immaginare una immortalità che sgorga dalle nostre mani. C’è in noi un Prometeo dormiente che «il più astuto degli animali» può ancora oggi svegliare. La Scrittura ci avverte a non lasciarci «incantare dal serpente» e a comprendere e a vivere con sapienza la nostra condizione di uomini e donne fragili, eppure destinati all’eterno.
La fragilità segna anche l’animo umano, la sua psiche, i suoi sentimenti. Sono suggestive le riflessioni del noto psichiatra Eugenio Borgna sugli aspetti luminosi e oscuri della condizione umana che ha molti volti e, in particolare, il volto della malattia fisica e psichica, della condizione adolescenziale con le sue vertiginose ascese nei cieli stellati della gioia e della speranza e con le sue discese negli abissi dell’insicurezza e della disperazione, ma anche il volto della condizione umana lacerata dalla solitudine e dalla non curanza, dallo straniamento e dall’angoscia della morte. Rimando alla lettura delle sue pagine ove accenna alle diverse fragilità proprie dell’umano: sono fragili (si rompono facilmente) le emozioni e anche le ragioni di vita, le speranze e le inquietudini, le tristezze e gli slanci del cuore; sono fragili le parole, le nostre parole umane, quelle con cui vorremmo aiutare chi sta male e quelle che desidereremmo dagli altri quando siamo noi a stare male. E si potrebbe continuare ancora.
Tutti vulnerabili
Tutti fragili. Ed anche tutti vulnerabili. Pierangelo Sequeri saggiamente afferma che vulnerabilità e fragilità rivelano un tratto costitutivo dell’umano-che-è-comune. Evocare la vulnerabilità del vivere significa asserire che la promessa inscritta nella vita quale garanzia e custodia del senso stesso del vivere è esposta al rischio di essere ferita, spezzata, interrotta. Il carattere autenticamente «umano» della vita, infatti, altro non è se non l’esperienza – enigmatica, ma reale – di una promessa, che interpella la coscienza a fidarsi di un senso che non solo la anticipa, ma la sostiene e la autorizza a decidersi e a rischiare la propria libertà; che la autorizza ad agire, ad amare, a soffrire, a sperare; in definitiva, a credere nella possibilità di arrivare a capo di quell’«enigmatico desiderio che fin dall’origine costituisce la segreta identità del soggetto stesso», ribellandosi, al contrario, contro il non senso e la non sostenibilità di tutto ciò che viene riconosciuto come minaccia per la consistenza e l’affidabilità della vita stessa.
Partiamo anche qui dal vocabolario. Il termine «vulnerabile» traduce l’aggettivo latino vulnerabilis, derivato dal verbo vulnerare la cui azione provoca un vulnus, una ferita. È vulnerabile chi può essere ferito in diversi modi: a livello fisico, materiale, psicologico, morale, sociale, etc. Tutti gli aspetti dell’esistenza sono segnati dalla vulnerabilità: le creature (umani, animali, vegetali) sono vulnerabili, in quanto esseri viventi sottoposti a trasformazioni, a invecchiamento e, in definitiva, destinati alla morte. Il filosofo francese Vladimir Jankélévitch ha lucidamente puntualizzato: «l’uomo è fondamentalmente vulnerabile» solo perché «la morte può entrare in lui attraverso tutte le giunture del suo edificio corporeo». Il che è come dire: ogni essere vivente «nasce» vulnerabile, dal momento che, fin dal suo primo istante di vita, egli è esposto al rischio radicale della «morte», la quale, del rischio, è il nome più proprio.
La vulnerabilità non è una scoperta recente. L’essere umano è sempre stato vulnerabile, fragile, e sempre lo sarà, «da capo a piedi, sino alle midolla delle ossa», come scrive efficacemente Lévinas. Al contempo, però, i significati attribuiti alla comune condizione di vulnerabilità sono variati con il mutare delle epoche e delle culture. Nell’attuale contesto socio-culturale la vulnerabilità sembra diventata una sorta di «cifra» sintetica dell’esistenza individuale e collettiva. Non a caso, la vulnerabilità è un concetto impiegato ormai abitualmente anche in chiave di analisi e di progettazione politico-sociale ed economica, ambiti dove viene a designare la concreta esposizione delle condizioni di vita individuali ai nuovi processi di impoverimento. La vulnerabilità, in questa accezione, presenta quindi il suo lato non solo individuale e privato, ma anche eminentemente pubblico, agendo da criterio ispirativo e regolativo di azioni sociali volte alla promozione e alla tutela del benessere e della dignità della persona.
Nel 1998, la vulnerabilità è stata riconosciuta come principio bioetico «propriamente europeo» dalla Dichiarazione di Barcellona, che la presenta in questo modo: a) La finitudine e la fragilità dell’esistenza umana su cui poggia, nelle persone capaci di autonomia, la possibilità e la necessità di ogni vita morale. b) La vulnerabilità è l’oggetto di un principio morale che richiede l’esercizio della cura nei confronti delle persone vulnerabili. Le persone vulnerabili sono quelle persone la cui autonomia, integrità e dignità possono essere minacciate. In questo senso tutti gli esseri umani, in quanto portatori di dignità, sono protetti da questo principio.
L’idea della vulnerabilità umana – l’ho già sottolineato prima – è emersa in contro-tendenza rispetto alla narrazione dominante della nostra modernità e della sua illusione sull’illimitato progresso umano ottenuto manipolando la natura a proprio piacimento. Questo scenario ha portato anche ad un atto d’accusa dell’antropocentrismo che ha dominato la cultura occidentale: la manipolazione della natura da parte dell’uomo sarebbe ormai talmente pervasiva, aggressiva, distruttiva da rendere l’uomo un pericolo per il diritto alla vita delle altre specie e per l’equilibrio cosmologico delle forme e delle forze che rendono abitabile il pianeta. Ma quel che è singolare è che la vulnerabilità riconosciuta alla natura non-umana non include un riconoscimento specifico della vulnerabilità propria dell’essere-umano, ossia come dimensione eticamente rilevante per l’analoga individuazione del dovere di protezione della sua dignità personale e di cura delle modalità relazionali di una convivenza all’altezza di tale dignità. È qui forse la ragione della battuta d’arresto del movimento ambientalista nei decenni dello sconvolgimento doloroso dell’umana convivenza prodotto dalla seconda guerra mondiale.
Il tema è stato posto con esplicita chiarezza – inedita nella tradizione del magistero cattolico – dall’enciclica di papa Francesco Laudato si’. La sua lettura, secondo i parametri dell’ecologismo estetico e utilitaristico, non è soltanto riduttiva: è un vero e proprio fraintendimento. Potremmo dire, con un pizzico di provocazione, che quell’insegnamento è piuttosto la prosecuzione del magistero sociale della Chiesa con altri mezzi, adeguati all’inedito profilo critico raggiunto dal rapporto fra cura della terra dei viventi e salvezza della dignità dell’essere umano. L’appello del papa si iscrive all’interno di una rilettura delle pagine bibliche relative alla «signoria» dell’uomo sulla natura. La custodia del Creato è parte integrante della vocazione dell’uomo e della donna e della loro stessa dignità. L’uomo e la donna – assieme, in una vera e propria alleanza, non semplicemente come individui separati – debbono esercitare la loro «signoria» sulla creazione nell’orizzonte di quella «immagine e somiglianza» del Creatore che in mille modi – pensiamo soltanto ai Salmi o al libro della Sapienza – viene celebrata come affezione provvidente per tutte le creature viventi, anche le più piccole e trascurate. Del resto, nel racconto di Noè che tutti conoscono, il gesto simbolico che indica la via della salvezza per la famiglia umana e la terra dei viventi comprende l’imbarco delle coppie di tutti gli animali, pulcini e pesci compresi. Insomma, il mito di Prometeo, che una volta fu posto al vertice del calendario secolare dell’ateismo intenzionalmente umanistico, ed ora è impugnato come ispiratore di una volontà di potenza che autorizza il dispotismo distruttivo della specie umana nei confronti della terra dei viventi, proprio non ci appartiene: né per tabulas, né come ispirazione.
L’essere umano è anch’esso costitutivamente vulnerabile e lo è in modo specifico, non soltanto biologicamente o psicologicamente: è intellettualmente e moralmente vulnerabile, nella sua natura più propria e più intima. Questa vulnerabilità, naturalmente, si fa sempre strada attraverso la mortificazione del corpo e della psiche. Tuttavia, essa mostra sempre, negli esseri umani, i tratti della sua correlazione con il bisogno di un riconoscimento intenzionale e di un apprezzamento personale che oltrepassano la fragilità e il limite psico-fisico che, infine, puntano alla certezza di una singolarità umana irrevocabile, inviolabile, insuperabile: in qualunque costellazione sociale, in qualsiasi contesto naturale. Questa consapevolezza è forse la parte migliore della nuova sensibilità antropologica che sta maturando in questo pur confuso e contraddittorio cambiamento d’epoca. La coscienza collettiva del profilo affatto speciale della vulnerabilità costitutiva dell’essere umano è un tratto nuovo della nostra evoluzione culturale.
Ha ragione Luigina Mortari nel sottolineare che «non solo non si può evitare la vulnerabilità connessa al nostro essere intimamente relazionali, ma le esperienze più significative sono proprio quelle dove la nostra vulnerabilità non è solo patita ma arrischiata, perché il fiorire dell’umano richiede non semplicemente, anche se mai è semplice, di stare con gli altri, ma apertura all’altro, tenerezza della mente, capacità di quella empatia che consente di comprendere la qualità del vissuto dell’altro, dedizione a cercare il benessere di chi amiamo con il rischio di sentirsi rifiutati proprio dove noi mettiamo in gioco noi stessi. In questo senso l’eccellenza umana presuppone di accettare fino in fondo la propria vulnerabilità e di essere arrischianti del rischio in cui la vita ci pone».
È dal secolo scorso che l’umanità è divenuta capace di distruggersi da sé, sia direttamente con la guerra nucleare, sia indirettamente con l’alterazione delle condizioni necessarie alla propria sopravvivenza. Il superamento di questa soglia era preparato da molto tempo, ma ha reso manifesto e critico quel che fino ad allora non era che un pericolo potenziale. In più, si è aggiunta la crisi che può nascere dalle nuove tecnologie emergenti e convergenti che intaccano direttamente l’umano: l’uomo può essere esaltato e assieme cancellato. Gli scenari che si aprono richiedono un nuovo impegno morale. Potremmo dire che l’istanza morale del rispetto e della responsabilità collettiva per l’uomo vulnerabile non è solo una deduzione del tema ecologico, né una variabile del calcolo economico. Jean-Marie Domenach parlava del «ritorno del tragico» nel mondo moderno.
La sensibilità per le vittime e la responsabilità dei vulnerabili è obiettivamente destinata ad illuminare una questione stantis aut cadentis della civiltà umana in quanto tale. Siamo pronti a prendere congedo dal nostro delirio di onnipotenza per riaprire l’orizzonte di una civiltà della compassione? La compassione che ci è richiesta non è la commiserazione sentimentale della disgrazia altrui, che ci procura sollievo per lo scampato pericolo, ma una vera e propria passione morale per la condivisione responsabile e fattiva della nostra comune vulnerabilità, a incominciare da quella che è minacciata dall’indifferenza, dalla rimozione, dall’abbandono. La vulnerabilità condivisa, attraverso la circolazione di una sensibilità che concepisce la sua inclusione nel progetto sociale complessivo, ci rende umani, tanto quanto la sua mortificazione condanna alla vana retorica ogni presunto progresso della civiltà del diritto e dei diritti.
Tutto lascia pensare che la riscoperta della vulnerabilità umana, avviata dalla riflessione antropolog
…
DA:
Estratto

Vincenzo Paglia
1945, Boville Ernica (FR)
Si è laureato in teologia, filosofia e pedagogia. Già vescovo di Terni, è Presidente della Federazione Biblica Internazionale. Di recente è stato nominato Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia ed elevato alla dignità di arcivescovo. Assistente ecclesiastico e consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio partecipa attivamente all’associazione “Uomini e Religioni”. Per il suo impegno per la pace ha ricevuto il premio Gandhi dall’Unesco e il premio Madre Teresa.
Giornalista e scrittore, è autore di libri di carattere religioso e sociale. Per Piemme ha pubblicato In cerca dell’anima. Dialogo su un’Italia che ha smarrito se stessa (2010) , Cercando Gesù. In un mondo sempre più confuso siamo ancora capaci di amore? (2012) (entrambi con Franco Scaglia), A un amico che non crede (2013), Sorella morte. La dignità del vivere e del morire (2016) e Vivere per sempre (2018).
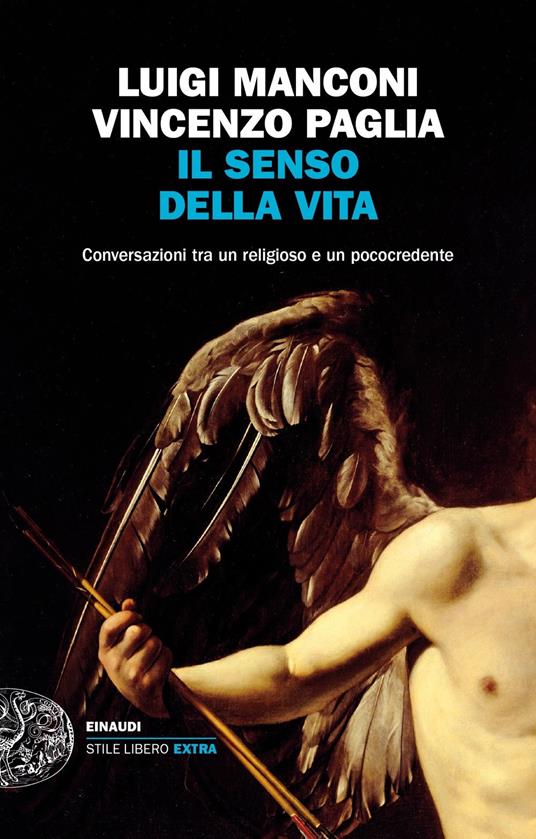
EINAUDI, 2021

PIEMME, 2021
Per alcuni è rassegnato passaggio verso anni di decadimento fisico, inoperosità forzata e solitudine. Per altri una lontana minaccia da sfuggire con l’aiuto di pratiche salutistiche e attività appaganti. Comunque la si viva, la vecchiaia spesso fa paura o porta con sé la malinconia del tramonto. Eppure è diventata un tempo importante dell’esistenza, ben più lungo di quanto era fino a pochi decenni fa, e si presenta, in mancanza di modelli, come un’età da inventare. Vincenzo Paglia, che da anni studia e si occupa delle esperienze e dei bisogni delle persone anziane, propone in queste pagine una visione penetrante e innovativa della vecchiaia. Un periodo libero dalla tirannia della produttività e disponibile per edificare legami, momenti di ascolto delle proprie domande e di quelle degli altri. Anni scanditi non più dal calendario degli impegni ma dal tempo degli affetti, della riflessione, del contributo offerto alla comunità. I vecchi insegnano la bellezza di trasmettere e prendersi cura della vita e quando, col corpo indebolito e la mente confusa, diventano faticosi e difficili da amare, ci ricordano che la fragilità è una condizione comune a tutti e l’autosufficienza una sciocca illusione. Questa consapevolezza della dipendenza come radicale bisogno umano è il grande dono della vecchiaia alle generazioni più giovani. Ed è, al tempo stesso, l’orizzonte spirituale che permette di dare senso al ciclo della vita, di proiettare le proprie speranze nel futuro di cui si sono gettati i semi e, infine, di sentire la vecchiaia stessa come un compimento, una destinazione verso l’Eterno.


Questi argomenti toccano le profondità del nostro essere. Parlarne ci fa sentire meno soli.