Mario Isnenghi
La storia siamo ma non sempre
da protagonisti

Mario Isnenghi (Venezia, 1938) è uno storico e accademico italiano.
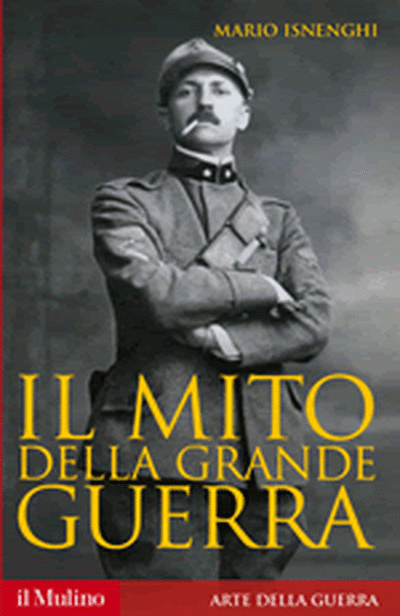
IL MULINO, 1970
di Antonio Gnoli

MARSILIO, 2021
Per essere uno storico, giustamente noto per le ricerche sulla Grande Guerra, Mario Isnenghi presenta qualche aspetto curioso. La sua venezianità, intanto. Cercata e affermata con caparbietà letteraria (suo il recente Se Venezia vive, edito da Marsilio dove, nel rifare il verso al manniano Morte a Venezia, ricrea un habitat culturale davvero poco esplorato).
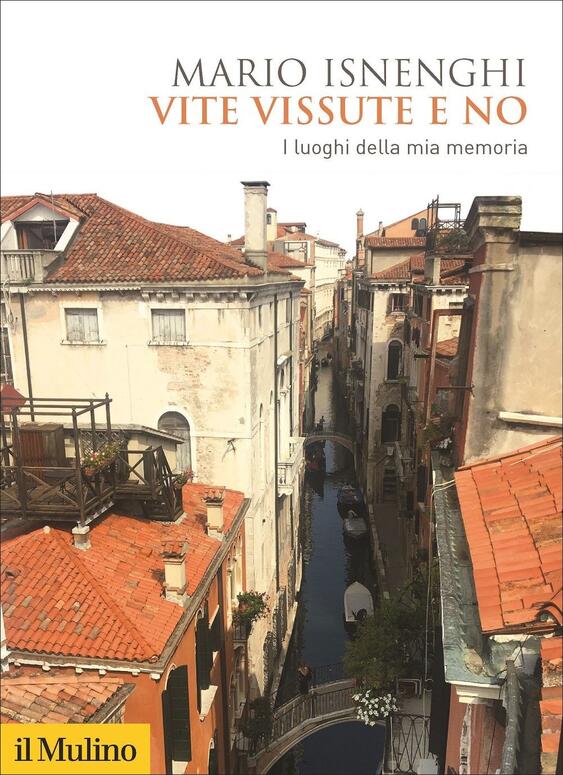
IL MULINO, 2020
E poi c’è quel suo consegnarsi autobiograficamente con Vite vissute e no, (edito da il Mulino), all’esplorazione di quell’enigmatico io-me che Isnenghi ha posto al centro della sua memoria; si tratta di un libro minuzioso, ellittico, divagante come un improvviso jazz. Musica fredda in una testa calda.
Il suo “io-me” è un buon compromesso tra lo storico e il letterato. Tra l’indagine oggettiva del me e quella soggettiva dell’io, più alata, incerta, sfuggente.
«A 84 anni lo storico – con tutti i suoi slanci positivistici – prova a diventare interprete di se stesso. E lo fa, ovviamente, affidandosi alla memoria. La mia funziona così: lo spazio è più netto e il tempo più sfumato. Per questo più del tempo della memoria mi interessano i luoghi della memoria. So collocare e visualizzare, ma non sempre datare con esattezza».
Il primo luogo che viene in mente è quello familiare. Dove scopriamo dell’esistenza di un genitore fascista, minacciato dagli altri fascisti e un suo tentativo di capire che cos’è un padre e cosa sono gli errori che commette. Come ha vissuto tutto questo?
«Sono vicende la cui discussione più che nella storia cade nella cronaca di una manciata di anni: dal 1943 al 1945. Un padre fascista travolto da un bel naufragio politico. A volte mi dicevo, pensa Mario che bello sarebbe stato, per il futuro dirigente degli Istituti storici della Resistenza, avere avuto un padre partigiano. Ma non è andata così, come non è andata così per migliaia di famiglie italiane».
Tutti vorremmo dei padri migliori.
«Ma nessuno li vorrebbe peggiori. Anche se a sua discolpa metterei la coerenza, l’essere stato fedele a se stesso, piuttosto che volersi rifugiare in quella zona grigia, di chi sta comodamente a guardare come andrà a finire. Oltretutto, non intraprese mai la militanza armata, non volle mai compiere quel passo violento; decisione che lo emarginò dagli altri fascisti. Mi dispiace concentrare in poche battute svolte complicate. Dopo la guerra papà fu mandato via dal suo lavoro. Poi l’epurazione fallì. Ma io resto il figlio di un epurato. E, colmo dell’ironia, quando nel mio lavoro a scuola venni licenziato, per ragioni politiche, sentii che un padre e un figlio avevano subito la stessa sorte, uno da destra e l’altro da sinistra».
Fu una vicenda che vi ha allontanati?
«No, ma poi su questo non c’è mai stata una vera parola tra noi. Il vecchio bambino che nel frattempo sono diventato ha provato a liberarsi da quel “fantasma”, avevo qualcosa di dire e senza narcisismi l’ho scritto nell’autobiografia».
Una vita raccontata come un piccolo teatro con molte zie e zii nella sua infanzia.
«Furono effettivamente i personaggi del mio teatrino: la risentita zia ligure, micro proprietaria terriera, cattolica e democristiana; la zia, più nonna paterna, di Riva sul Garda, grande affabulatrice; lo zio Luigi un patriarca poco venerando, circondato di boccette medicinali al suo letto di morte, rimandata di anno in anno, costretto dal parroco a sposare la sua cameriera. Ma sono ricordi dove la filologia parla troppo remissivamente dentro di me, sovrastata da quell’effetto alone che producono le mitologie familiari».
Ha un modo molto letterario di raccontarsi.
«La letteratura ha avuto una certa preponderanza nella mia formazione».
Cosa leggeva?
«Quello che passavano le biblioteche di famiglia. A Venezia erano i libri di mia madre e di sua sorella, studentesse a Ca’ Foscari negli anni Trenta. E poi a Riva, luogo di tante estati e culla delle mie genealogie mentali, incrociavo letteratura d’appendice, romanzi femminili, ma anche Nievo e Fogazzaro e poi ricordo due sontuose serie rilegate di romanzi di Verne. Lettura designata forse dall’unico lontano zio maschio in una infinita serie di sorelle quasi tutte morte giovani di tisi, almeno secondo le diagnosi del dottor Fiorio, medico delle famiglie bene rivane».
Com’era a scuola?
«Ero un piccolo professionista dell’apprendimento, benvoluto dagli insegnanti e additato ad esempio dalle madri. Trattato da primo della classe senza esserlo.
Bravo solo in italiano. Conservavo uno stile riconoscibile e apprezzato. Quando all’esame di abilitazione mi fu chiesto della “Pace di Caltabellotta” esplose il Bignami che era in me: 1302, risposi. Voglio dire che mi bastava un buon scritto di italiano e venti giorni di “Bignami” cioè di date mandate a memoria, perché la buona figura fosse assicurata».
Ha avuto un’educazione cattolica?
«In famiglia, come tutti: messa alla domenica, patronato da suore e frati, confessione e comunione quanto basta. Fisiologia spicciola del non possiamo non dirci cristiani».
Però crescendo c’è stato il rapporto con la Fuci, la federazione universitaria cattolica italiana dalle cui fila sono usciti fior di democristiani, ma anche cattolici come Vittorio Bachelet.
«Per me la Fuci è stata la scoperta che si poteva anche essere cristiani per davvero, con un ardore che non era il mio e del mio ambiente, conformista e tiepido. Salvo poi, quando arrivavano le elezioni, precipitare da quelle altezze in un’ammucchiata elettorale».
Non so se definirla uno storico cattolico. Forse no.
Ma gli storici cattolici sono stati quasi sempre messi al margine del grande dibattito pubblico. Penso a Gabriele De Rosa.
«La verità è che la storia contemporanea nasce per grandi aree o famiglie politico-culturali che studiano se stesse, cioè gli antenati, nella storia dell’Italia unitaria.
Ovviamente, per i cattolici non è stato un bel vedere».
Cosa intende?
«Hanno dovuto affrontare il complicato rapporto tra la Chiesa e lo Stato. Una vicenda che è restata incerta almeno fino a quando nel secondo dopoguerra Piero Scoppola ha valorizzato il filone cattolico-democratico. Il messaggio era chiaro: fatevi andar bene De Gasperi altrimenti vi beccate Gedda».
Ritiene ci sia stata un’egemonia culturale di sinistra e in particolare del Pci?
«Tutta questa egemonia del Pci io non l’ho vista, almeno nell’ambito delle cose di cui mi sono occupato.
Ho fatto parte del piccolo mare ribollente della sinistra socialista, non il mare dell’ortodossia comunista, sospettosa e chiusa alla nuova sinistra. Per me, e per tanti dei miei coetanei, gli intellettuali-politici di riferimento erano Gianni Bosio, Franco Fortini, Vittorio Foa, Raniero Panzieri. C’è un Psi prima di Craxi che andrebbe riscoperto».
Lei ha avuto un rapporto di collaborazione con casa editrice Einaudi. Che funzione culturale e politica ha svolto?
«Una funzione propositiva, basta sfogliare il catalogo.
Quanto ai miei rapporti, si sono stretti con alcune persone: Paolo Fossati e Carmine Donzelli che seguì il lavoro sul Veneto, erano quei volumi dedicati alla Storia d’Italia. Giulio Einaudi non l’ho mai visto. Una presenza dialettica è stata Norberto Bobbio, con il quale ci siamo più scritti che visti. Non si dava pace che io insistessi a studiare la cultura del fascismo che – notoriamente per lui – non esisteva».
A proposito di Veneto e di Venezia, cui ha dedicato il suo ultimo libro, a chi si sente di appartenere?
«A me non verrebbe mai in mente di dichiararmi “veneto”. Senza offesa, io mi sento veneziano. Per me studiare il Veneto è stato il modo migliore per studiare l’Italia dal punto di vista del protagonismo cattolico».
Quanto a Venezia?
«Sin dal titolo – Se Venezia vive – ho cercato un contravveleno alla “morte a Venezia”, genere letterario purtroppo invalso come paraocchi ideologico. Ho raccontato quel che veramente è accaduto nell’Otto e Novecento e spiegato perché questa è una storia senza memoria. Nel libro do molto peso al 1848-49 a Venezia, un Quarantotto di lunga durata, senza paragone in Europa, eppure lasciato orfano dai suoi stessi autori e attori».
Lei ha realizzato un importante trilogia sulla Grande guerra. Una sua tesi è che la vittoria sia stata trattata quasi come una sconfitta – o meglio una vittoria di cui vergognarsi – così come la sconfitta subita nel 1943-45 la si è vista quasi come fosse stata una vittoria. Cos’è che non funziona nel nostro rapporto col passato?
«Quello che io ho notato, fra le altre cose, è la tendenza incoercibile a sputarsi addosso: come vogliono – in velenosa sinergia – gli Antitaliani sia di destra che di sinistra. Pensare di aver perso la Grande guerra, avendola in realtà vinta, è un grottesco harakiri praticato da maître-à-penser come D’Annunzio o Prezzolini: retorica dell’antiretorica. Quanto alla sconfitta nella seconda guerra ha fatto cadere il regime fascista. La Resistenza è stata importante e guai se non ci fosse stata».
Che storico pensa di essere?
«Non sono uno storico economico né un metodico frequentatore di archivi. Penso di essermi affinato nel far parlare i testi, che non sono solo scritti ma composti di situazioni, gesti, personaggi, passaggi di fase. E poi sono contento di aver fatto storia dell’Italia unitaria mentre si mettevano in dubbio sia la storia che l’Italia».
C’è molta indagine letteraria nelle sue ricerche, al punto che una volta lei si è definito accademicamente “bisessuale”. La miglior storia dunque non ha confini disciplinari?
«Io dipendo dalle storie settoriali e sono ben contento che esistano gli specialisti, me ne servo e li benedico.
Detto questo, a me piacciono gli affreschi, i murales – da Simone Martini a Massimo Campigli; o le cene del Veronese. Anche l’arte appartiene agli spazi della memoria così come la letteratura ai suoi luoghi».
Lei ha sostenuto che la migliore opera sull’Italia è la storia letteraria di Francesco De Sanctis. Siamo un paese percepibile più per categorie artistico letterarie che politiche?
«Se intende alludere alla matrice elitaria sono d’accordo. Ma questa divaricazione tra letteratura e politica non la vedo. Impariamo dai Promessi sposi a non metterci nei trambusti e da Le confessioni di un italiano a non farcene mancare quasi nessuno. Sono due politiche, due stili di comportamento, diciamo pure di cittadinanza. Ma non sarà irrilevante che in questo paese ci è stato sempre fatto leggere molto più Manzoni che Nievo».
Consiglierebbe a un giovane di leggere oggi “Le confessioni di un italiano”?
«È quello che faccio da sempre , puntando come programma massimo a sostituirle ai Promessi sposi, Bibbia del moderatismo e del “tengo famiglia”. Debbo a Nievo, almeno in parte, il licenziamento come insegnante, agli esordi del mio insegnamento. Il mio impegno civile, su cui scrissi un libello, fu una gloriosa disfatta».
Oggi la storia è in crisi, insidiata dal presentismo. Siamo davvero nella grande bolla del presente?
«Temo proprio di sì. Ma poi, come negli andamenti atmosferici, passa. La storia non ha un percorso unilineare. Io la vedo come una serie di tornanti e non penso sia finita. C’è ancora la possibilità di invertire le cose rispetto al dominio delle multinazionali, delle grandi piattaforme tecnologiche e del capitalismo finanziario.
La “storia siamo noi”, ha richiamato il presidente Mattarella, alludendo a una canzone famosa di De Gregori.
«Siamo noi, nel senso che non la troviamo bella e fatta. Si fa lungo la strada. Quel “noi” però non è quasi mai vero protagonismo. La storia un po’ si fa e un po’ si subisce».
La storia invecchia?
«Certo che invecchia e muta. Valori e principi che pensavamo fossero assoluti si relativizzano o si capovolgono».
Cos’è per lei la vecchiaia?
«Di fronte ad essa, come di fronte a Dio, resto incredulo».
Condividi

