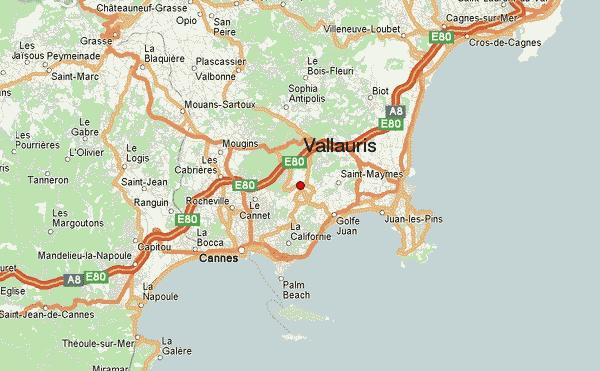
Nell’agosto del 1946, mentre in vacanza a Golfe Juan, in Provenza,con Françoise Gilot, Picasso visita una mostra di artigianato locale a Vallauris. Qui incontra Suzanne Ramiè, che aveva creato un atelier alcuni anni prima in una dei vecchi laboratori abbandonati della città. Quel pomeriggio, Picasso produsse diversi pezzi tra cui una piccola testa di fauno e due tori: l’inizio di un’avventura e di una collaborazione con la famiglia Ramié che sarebbe durato 25 anni. I Ramiés lo accolsero a tempo pieno nel loro laboratorio l’anno successivo, e tra il 1947 e il 1971 avrebbe continuato a produrre un corpus di ceramiche unico e 633 piatti diversi, ciotole, vasi e brocche, in edizioni limitate che vanno da 25 a 500. Tuttora questi pezzi, che non hanno costi stratosferici costituiscono un ottimo investimento.La produzione di Vallauris era strettamente artigianale fin dall’antichità, ma in quegli anni il mercato era economicamente crollato.
Per ben dieci anni, Picasso coltivò una collaborazione piena con i Ramiè ed al loro atelier trasferendo il proprio studio in una vicina fabbrica di profumi abbandonata e stabilendosi in un cascinale sulle alture del paese.
Picasso come Matisse iniziò dipingendo e decorando piatti, vasi e boccali e conferendo loro, spesso con pochi tratti, segni saettanti o incisioni rapide, un aspetto tutt’altro che artigianale.
Indovinata la scelta, cominciò presto a modellare le forme, e tra colombe, gufi, figure e piastrelle diede a Vallauris una tal fama che ad ogni compleanno dell’artista, il paese gli organizzava una festa così ricca da sembrare la celebrazione del santo patrono. Veniva organizzata anche una corrida con tanto di Corrida e di Platea con posto d’onore da primo cittadino.
NEL BREVE FILMATO, PICASSO NEL LABORATORIO PROVENZALE
Condividi





Anni fa avevo visto al Museo Picasso a Parigi ( non era ancora stato ristrutturato, credo che ora sia molto più ampio) delle ceramiche dell’artista: erano le opere che più mi erano piaciute, forse perché più facilmente comprensibili.
Non c’entra niente, ecc. ecc. : ieri ho visto in televisione, su RAI Storia, un film molto interessante: ” Il fondamentalista riluttante”, tratto da un libro dello scrittore pakistano Mohsin Hamid. Il regista è Mira Nair. E’ la storia di un giovane pakistano di Lahore, proveniente dalla piccola-media borghesia, che riesce ad entrare nella prestigiosa università USA di Princeton. Si laurea ” summa cum laude” in scienze economiche e viene assunto da una tra le più importanti società americane che fanno analisi finanziarie in tutto il mondo per le ditte in difficoltà. Queste analisi si traducono il più delle volte in licenziamenti di dipendenti.
Il giovane pachistano, che vive e lavora a New York, sembra integrarsi bene in questo genere di lavoro, finché non arriva l’11 settembre del 2001 con l’attentato terribile alle Torri Gemelle. Il giovane brillante laureato viene fermato più volte dalla polizia, con umilianti perquisizioni corporali, solo per il suo aspetto fisico che ne fa immediatamente un sospettato. La ragazza newyorchese, di cui si era innamorato e che sembrava corrisponderlo, si rivela invece per un’artista in cerca di ispirazione. Decisivo è il suo viaggio, per la società per cui ancora lavora, a Istambul: si tratta di un editore che è stato importante per la cultura turca,che ha fatto conoscere nel suo Paese opere del vicino Oriente, ma che ora sta fallendo. L’editore aveva a suo tempo pubblicato un libro di poesie del padre di Changer ( il giovane protagonista pakistano). La crisi esistenziale arriva al culmine: il brillante analista si rifiuta, come vorrebbe invece il suo capo, di fare fallire l’editore e sceglie di tornare in Pakistan. Qui viene assunto come docente universitario e le sue lezioni sulla società americana, di cui mette in luce gli aspetti positivi e negativi, diventano popolari tra i giovani studenti. Viene avvicinato da uomini dei servizi, sia americani che pakistani, gente che fa doppi e tripli giochi. Non cade nelle varie trappole ma in una rivolta spontanea, proprio mentre lui sta cercando di far sì che la polizia non spari, un suo studente tra i più generosi e convinti della necessità di uno Stato più indipendente dall’esercito e dagli Stati Uniti, viene colpito a morte dalla polizia pakistana. Il film termina con i funerali dell’ucciso e con i bellissimi versi, versi d’amore per esorcizzare la morte, pronunciati dal protagonista. Il film, dove c’è una tensione che sale mano a mano che si va verso la fine, è da vedere soprattutto per la conoscenza di un mondo da noi così distante. Si tratta anche, e principalmente, di una lezione di pulizia intellettuale: i bravi e i cattivi esistono solo nelle menti di chi vuole semplificare la realtà. Esistono persone reali che rifiutano, con grande travaglio personale, di non fare i ” giannizzeri”. Come spiega l’editore turco al giovane analista, i giannizzeri erano un corpo speciale alle dirette dipendenze del sultano turco: catturavano bambini cristiani nelle zone occupate, li allevavano nella fede assoluta all’Islam e poi, diventati giovani adulti, li mandavano a sterminare la loro famiglia d’origine come prova suprema di fedeltà. Il giovane pachistano non vuole essere un giannizzero per nessuno.
Un film che ho visto di recente e che si trova in molte sale italiane è ” Gli sdraiati” di Francesca Archibugi, tratto dall’omonimo libro di Michele Serra, edito pochi anni fa da Feltrinelli.
La trama si svolge a Milano: il protagonista, bene interpretato da Claudio Bisio, è un uomo di successo che presenta programmi in RAI. Anni prima, dopo la separazione, ha ottenuto l’affido condiviso e si occupa del figlio adolescente Tito. Il figlio diciassettenne, studente liceale, è circondato da una banda di suoi amici, che passano la maggior parte del tempo libero sdraiati sui divani di casa a ” cazzeggiare”, a vedere la televisione o a giocare con i videogiochi. Il padre è in rotta col figlio , ma non riesce minimamente a rompere quel muro di silenzio e di incomprensibile ostilità da parte di Tito. Anzi, ai suoi rimproveri più che giustificati ma assillanti, il figlio risponde con l’indifferenza più assoluta. Nella vita del giovane entra una ragazza, altrettanto scostante come lui verso il mondo degli adulti. Si sviluppa forse un sentimento spontaneo, soprattutto da parte del ragazzo. Ci sarà un incidente ( il ragazzo cade dal tetto della scuola) che farà ( forse, e ce lo auguriamo) avvicinare padre e figlio. A far maturare l’adolescente ci sarà anche la morte del nonno materno che, distanziato per l’età e l’esperienza dal nipote, riusciva da lui a farsi ascoltare. Forse l’esperienza di realtà, non solo vissute come spettatori, farà maturare il rapporto tra padre e figlio.
Il film, non banale, riesce a fotografare una situazione di disagio della famiglia: il capovolgimento del rapporto padre-figli, dominato da una specie di dittatura che permette tutto ai giovani e vede i padri senza strumenti per indirizzare i figli, di cui pure vedono i difetti. Forse il film può essere anche una riflessione sui rapporti che noi stessi, giovani generazioni degli anni Sessanta e Settanta, abbiamo avuto con la nostra famiglia, pur facendo le debite distinzioni storiche. I giovani borghesi di oggi non hanno in apparenza nulla con cui scontrarsi, sono appagati nei loro desideri materiali ma manca la molla per cui muoversi. Eppure, anche se i grandi ideali del Sessantotto sono stati cancellati da una realtà spietata e univoca, covano sotto la cenere per riapparire ( speriamo presto) nella realtà di tutti i giorni. Cos’è infatti quel senso di frustrazione che proviamo tutti davanti ad una serie televisiva ben confezionata o a un videogioco che ci fa sentire protagonisti anche se siamo coscienti che non lo saremo forse mai?